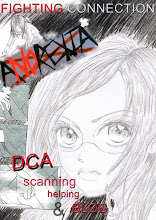Visualizzazione post con etichetta DSM. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta DSM. Mostra tutti i post
venerdì 6 marzo 2015
Chiunque abbia l'anoressia ha solo paura d'ingrassare? Possiamo incolpare la società occidentale?
Una cosa che trovo divertente dell’aver posto un tracciante sul mio blog, è vedere quali parole conducono le persone al mio angolo virtuale; l’altra faccia della medaglia è ovviamente rappresentata dal fatto che non posso interagire direttamente con queste persone. Questo post rappresenta dunque, per lo meno in parte, un tentativo di rispondere ad una delle più comuni domande che indirizza le persone verso il mio blog. Domande frequenti sono varianti delle seguenti: “le modelle troppo magre causano l’anoressia?”, “relazione tra anoressia e immagini di modelle eccessivamente magre”, “le foto delle modelle nei giornali causano l’anoressia?”, “anoressia e ragazze che vogliono essere come le modelle”, “il ruolo della società nell’anoressia”, “pensieri dei medici su come le modelle magre causano l’anoressia”, “la società e l’eccessiva magrezza sono da incolpare per l’anoressia?”.
Ecco, questo è il punto.
Ho già affrontato questa tematica in diversi post, l’ultimo di questi era quello in cui disquisivo su alcuni Case Report che si occupavano dei DCA in donne non vedenti, ma già in passato avevo parlato di come l’idea – ovvero il luogo comune – che va per la maggiore tra la gente sia quello che la società occidentale promuove un’ideale di magrezza che causa l’anoressia e che le ragazze con questa malattia hanno paura d’ingrassare.
Questo luogo comune, insieme all’idea che i DCA non esistano nei paesi non-occidentali (o che compaiano solo quando essi risentano dell’influenza dei mass media occidentali), come è emerso anche dal commento che Rosa ha lasciato al mio post precedente, è spesso accettato come fosse un dato di fatto.
Rieger e i suoi colleghi, in un loro studio, hanno cercato di esaminare se questi luoghi comuni fossero effettivamente fondati o meno. Più nello specifico, il loro obiettivo era quello di: “Esaminare in maniera critica 2 luoghi comuni sulla correlazione tra società, peso e anoressia: 1) che la preoccupazione per il proprio fisico è una specifica manifestazione occidentale contemporanea della malattia e 2) che la diffusione della cultura occidentale è responsabile dello sviluppo dell’anoressia nei Paesi non-occidentali. [Per condurre] una review della letteratura empirica e teoretica sugli aspetti culturali dell’anoressia nervosa e sulle cartelle cliniche di 14 donne asiatiche trattate per DCA a Sydney, in Australia.” (mia traduzione)
In sostanza, questi ricercatori sostengono che è il desiderio di perdere peso come forma di controllo piuttosto che la paura di prendere peso a rappresentare una caratteristica distintiva dell’anoressia, e che l’interazione della cultura occidentale nei paesi non-occidentali non è la sola, e men che meno la principale, causa di anoressia, ma semmai tutt’al più una delle millemila concause che stanno alla base di una malattia notoriamente multifattoriale.
Il loro non è un articolo di primo piano né una review omnicomprensiva, ma credo che sia comunque una review che dà molto da pensare, e che tira fuori degli aspetti veramente convincenti ed importanti.
Per come stanno le cose ad oggi, una diagnosi formale di anoressia nervosa, usando il DSM, richiede che le pazienti presentino:
• “intensa paura di acquistare peso o di diventare grassi, anche quando si è sottopeso.” e
• “Alterazione del modo in cui il soggetto vive il peso o la forma del corpo, o eccessiva influenza del peso e della forma del corpo sui livelli di autostima, o rifiuto di ammettere la gravità della attuale condizione di sottopeso” Il criterio del peso (“al di sotto dell'85% rispetto a quanto previsto”) e l’assenza di mestruazioni (amenorrea) sono altrettanto controversi (ne ho già discusso in passato in altri post, quindi evito di ripetermi).
Questi criteri sarebbero dovuti cambiare nell’ultima edizione del DSM, e nella fattispecie il criterio dell’amenorrea avrebbe dovuto essere eliminato… in realtà, però, leggendo il DSM-V si vede che detti criteri sono rimasti per lo più invariati:
• “Intensa paura di aumentare di peso o di ingrassare, o comportamento persistente che interferisce con l’aumento di peso, nonostante un peso significativamente basso.”
• “Anomalia nel modo in cui è percepito il peso o la forma del proprio corpo; inappropriata influenza del peso o della forma del corpo sulla propria autostima, o persistente perdita della capacità di valutare la gravità della attuale perdita di peso.”
In sostanza, Rieger e i suoi colleghi valutano se questi criteri siano validi (Non esattamente, in effetti, perché quest’articolo è stato pubblicato nel 2001, dunque prima della revisione della corrente edizione del DSM, ma francamente penso che i redattori del DSM avrebbero tratto grosso beneficio dal leggere questo articolo).
Com’era già chiaro dal 1995, quando uno psichiatra inglese, Gerald Russell, scrisse:
“Può darsi che si stia avvicinando il momento in cui sarà opportuno rivedere i nostri criteri diagnostici per l’anoressia nervosa, perché credo ci sia una falsa precisione nella formulazione attuale.” (mia traduzione)
Tra l’altro, Russell è stato il primo a pubblicare una descrizione della bulimia nervosa (e, sì, il “Segno di Russell” ha proprio preso il nome da lui).
Natura delle preoccupazioni per il peso nell’anoressia
Studi cross-culturali suggeriscono che la preoccupazione per il peso è minore nelle pazienti non-occidentali rispetto a quelle occidentali. Per esempio, in uno studio di 70 pazienti cinesi di Hong Kong, meno della metà riportavano preoccupazione per il proprio peso durante la fase più acuta della malattia. Tuttavia, queste donne attribuivano la loro perdita di peso ad inappetenza, epigastralgie o dolori addominali, il che suggerisce che la diagnosi di anoressia nervosa poteva essere del tutto inappropriata: una perdita di peso legata a perdita di appetito (nota bene: nel gergo medico l’ “inappetenza” si traduce con “anoressia” – ma NON “anoressia nervosa”!!) è piuttosto un segno di depressione – non di anoressia nervosa.
Rieger suggerisce che quello che è estremamente comune (universale?) nei casi di anoressia nervosa (“ciò che la distingue da ogni altra condizione patologica”) è la natura egosintonica del disturbo. Più specificatamente, il fatto che “la magrezza estrema non è percepita dalle pazienti come un reale problema: per quanto consapevoli che potrebbero averne dei danni di salute, continuano comunque a perseguirla perché questo le fa stare bene e le fa sentire come se avessero tutto sotto controllo”.
Rieger quota la descrizione di una paziente fatta da Charles Lasègue nel lontano 1873:
“[…] soprattutto, lo stato di quiete, potrei quasi dire uno stato di appagamento davvero patologico. Non solo [la paziente] non mostrava alcun interesse nel farsi curare, ma era sostanzialmente soddisfatta della sua condizione, pur comprendendo i potenziali rischi per la sua salute. Comparando questo stato di soddisfazione con l’ostinazione a proseguire un percorso patologico, non credo che arriverò molto lontano. Comparando invece tutto questo con le altre forme di anoressia, non posso che osservare quale enorme divario vi sia. […]” (mia traduzione)
Nota a margine: la parola “magrezza” NON è contemplata nella prima descrizione dell’anoressia nervosa da parte di Lasègue.
Un’altra interessante paziente la troviamo in uno studio condotto da Ciseaux nel 1980: “[…] è come se [la paziente] non capisse cosa significa prendersi cura della propria salute. Sostiene che più dimagrisce, o comunque si mantiene magra, meglio si sente […] orgogliosa delle proprie capacità di controllo […] come se la restrizione alimentare fosse diventata la cosa più importante che abbia mai fatto nella sua vita. […]” (mia traduzione)
Rieger evidenzia altri esempi di pazienti che non contemplano affatto la paura di prendere peso od ingrassare:
“[…] la restrizione alimentare dà un senso di grande potere, le pazienti provano la sensazione soddisfacente di avere tutto sotto controllo, e questo serve a perpetrare la patologia e a mantenerne la natura egosintonica. […]” (mia traduzione)
Insomma, quello che si evince è che, nelle varie pazienti, la restrizione alimentare e la correlata conseguente perdita di peso viene vissuta come fortemente egosintonica.
Rieger conclude la prima parte dello studio citando Russell:
“La paura di prendere peso sembra essere piuttosto una conseguenza, che non una caratteristica in sé, dell’anoressia nervosa, e non è comunque presente in tutte le pazienti. Quello che invece è costante ed immutabile in tutte le pazienti è il fatto che la natura della patologia è fortemente egosintonica, che è guidata dalla percezione di una sensazione di controllo, e che questo controllo esteso alla propria alimentazione e al proprio corpo permette alle pazienti di venire a capo dei propri conflitti interiori tacitandoli e illudendosi così di averli risolti.” (mia traduzione)
Natura delle preoccupazioni per il peso nell’anoressia in Paesi non-occidentali.
È stato – e tuttora purtroppo è – luogo comune sui DCA il credere che esistano solo nel mondo occidentale, e che la loro comparsa nelle minoranze di immigrati sia legata all’influenza della cultura e dei mass media occidentali: l’internalizzazione di un ideale di magrezza. Alcuni ricercatori avevano provato ad attribuire la differente prevalenza dei DCA nei vari Paesi non-occidentali al diverso “livello di occidentalizzazione” di suddetti Paesi.
Questo tentativo di attribuzione, ovviamente, non tiene conto dei casi di anoressia che comunque si sono verificati ben prima che il modello di magrezza fosse quello dominante nella società. Quel che è certo è che, quando William Gull e Charles Lasègue descrivevano casi di anoressia, la parola “magrezza” non viene MAI menzionata.
Ad oggi esistono studi che mirano a dimostrare che esiste una correlazione tra modelli proposti dalla civiltà occidentale, preoccupazione per la propria fisicità, e DCA, e allo stesso tempo esistono altrettanti studi che mirano a dimostrate che detta correlazione è inesistente.
Per esempio, uno studio rivela che nelle ragazze asiatiche emigrate in Inghilterra, la restrizione alimentare era correlate a valori tradizionali (e NON occidentali) (Hill & Bhatti, 1995). Questa conclusione è supportata da un ulteriore studio condotto da Mumford e i suoi colleghi nel 1991, che rileva la medesima correlazione. Hoek ed i suoi colleghi, in uno studio del 1998, rivelano che la prevalenza dell’anoressia nella popolazione generale di un’isola caraibica era la medesima dei Paesi occidentali, e uno studio di Apter et al. nel 1994 mostra che in un gruppo di villaggi musulmani le donne mostravano le medesime psicopatologie alimentari di pazienti occidentali affette da anoressia.
Fare studi cross-culturali è, tuttavia, molto difficile: innanzitutto, i test e gli strumenti utilizzati per valutare le pazienti in un Paese, sono applicabili, adeguati e rilevanti per pazienti di un altro Paese? E mentre tali problemi metodologici possono spiegare i risultati contraddittori ottenuti, Rieger suggerisce che questo “può essere dovuto ad una possibilità raramente presa in considerazione: che a prescindere dalla provenienza geografica, l’anoressia può rappresentare comunque una strategia di coping che viene messa in atto a prescindere da tutto.”
Gli autori hanno preso in esame anche le cartelle cliniche di 14 pazienti asiatiche affette da anoressia e bulimia, trattate a Sydney, in Australia. Tutte le pazienti riferivano di aver vissuto la restrizione alimentare come egosintonica, ma solo alcune di esse riferivano di aver paura di riprendere peso/ingrassare. Pur non mostrando particolare paura nei confronti del riprendere peso, alcune delle pazienti si rifiutavano di prendere in considerazione la gravità clinica della loro condizione di sottopeso.
Parlando della mia esperienza personale (quanto di meno scientifico possa esserci, insomma…), effettivamente io non ho mai avuto paura di riprendere peso, ed ero anche consapevole del fatto che il mio regime di restrizione alimentare era insalubre ed avrebbe potuto recare danni alla mia salute: tuttavia avevo talmente tanto bisogno di sentirmi in controllo, che le preoccupazioni sulla salute scivolavano in secondo piano. Non mi interessava il peso in sé (tant’è che non mi sono mai pesata, nemmeno nella fase più acuta dell’anoressia), anzi, avrei preferito poter continuare a restringere l’alimentazione pur mantenendo costate il mio peso (cosa impossibile, ovviamente) affinchè nessuno se ne accorgesse e io potessi continuare a restringere l’alimentazione per sentire il senso di controllo che mi trasmetteva. Infatti non m’interessava il perdere peso, mi interessava solo il meccanismo della restrizione alimentare perché mi faceva percepire questo (illusorio) senso di controllo: l’anoressia era una strategia di coping strettamente connessa al mio patologico bisogno di controllare ogni singolo ambito della mia vita. Difatti nel momento in cui, durante il mio percorso di ricovero, sono arrivata a comprendere a pieno questo (inizialmente ne avevo una consapevolezza molto parziale), seguire l’ "equilibrio alimentare" è diventato relativamente semplice.
Tornando allo studio in questione, Rieger e i suoi colleghi lanciano anche dei suggerimenti per studi futuri miranti a valutare la validità dei loro assunti. In sostanza, dicono che i futuri studi dovrebbero essere più esplorativi e aperti alle più svariate interpretazioni. Dicono che dovrebbero andare oltre i soliti test per DCA standardizzati nei Paesi occidentali, e affrontare la tematica con meno pregiudizi lasciando aperto il campo a tutte le ipotesi possibili: valutare per esempio se anche nei Paesi non-occidentali ci siano degli ideali di magrezza su basi culturali o religiose o tradizionali, perché affezionarsi ad ipotesi sbagliate può in definitiva limitare la comprensione dell’anoressia, per cui è importante esaminare criticamente ogni possibile ipotesi.
Per come la vedo io, la domanda centrale è: qual è la caratteristica distintiva dell’anoressia? E’ la paura di prendere peso, e dunque chi non ha questa paura rappresenta un caso “atipico” di anoressia, o è l’ampiamente applicabile criterio dell’egosintonico desiderio di restringere l’alimentazione? Io voto a favore dell’egosintonia: ritengo che l’egosintonica natura della patologia sia ciò che veramente definisce l’anoressia. E, egosintonicamente parlando, suppongo anche di aver ragione.
Se mi rifaccio alla mia esperienza, infatti, io non volevo affatto dimagrire (ero magra già in partenza), anche perché questo comprometteva le mie prestazioni sportive, però volevo restringere l’alimentazione perché mi faceva sentire in controllo. A suo modo, mi faceva stare bene. E io volevo sentirmi in quel modo. Secondo me, queste sono ragioni profondamente egosintoniche, anche perchè non m’interessava il peso in sé.
E voi, ragazze, cosa ne pensate? Qual è stata la vostra esperienza? Quale pensate sia il ruolo della paura di riprendere peso nell’anoressia? E dell’egosintonia? Se vi va, scrivetelo nei commenti!
Ho già affrontato questa tematica in diversi post, l’ultimo di questi era quello in cui disquisivo su alcuni Case Report che si occupavano dei DCA in donne non vedenti, ma già in passato avevo parlato di come l’idea – ovvero il luogo comune – che va per la maggiore tra la gente sia quello che la società occidentale promuove un’ideale di magrezza che causa l’anoressia e che le ragazze con questa malattia hanno paura d’ingrassare.
Questo luogo comune, insieme all’idea che i DCA non esistano nei paesi non-occidentali (o che compaiano solo quando essi risentano dell’influenza dei mass media occidentali), come è emerso anche dal commento che Rosa ha lasciato al mio post precedente, è spesso accettato come fosse un dato di fatto.
Rieger e i suoi colleghi, in un loro studio, hanno cercato di esaminare se questi luoghi comuni fossero effettivamente fondati o meno. Più nello specifico, il loro obiettivo era quello di: “Esaminare in maniera critica 2 luoghi comuni sulla correlazione tra società, peso e anoressia: 1) che la preoccupazione per il proprio fisico è una specifica manifestazione occidentale contemporanea della malattia e 2) che la diffusione della cultura occidentale è responsabile dello sviluppo dell’anoressia nei Paesi non-occidentali. [Per condurre] una review della letteratura empirica e teoretica sugli aspetti culturali dell’anoressia nervosa e sulle cartelle cliniche di 14 donne asiatiche trattate per DCA a Sydney, in Australia.” (mia traduzione)
In sostanza, questi ricercatori sostengono che è il desiderio di perdere peso come forma di controllo piuttosto che la paura di prendere peso a rappresentare una caratteristica distintiva dell’anoressia, e che l’interazione della cultura occidentale nei paesi non-occidentali non è la sola, e men che meno la principale, causa di anoressia, ma semmai tutt’al più una delle millemila concause che stanno alla base di una malattia notoriamente multifattoriale.
Il loro non è un articolo di primo piano né una review omnicomprensiva, ma credo che sia comunque una review che dà molto da pensare, e che tira fuori degli aspetti veramente convincenti ed importanti.
Per come stanno le cose ad oggi, una diagnosi formale di anoressia nervosa, usando il DSM, richiede che le pazienti presentino:
• “intensa paura di acquistare peso o di diventare grassi, anche quando si è sottopeso.” e
• “Alterazione del modo in cui il soggetto vive il peso o la forma del corpo, o eccessiva influenza del peso e della forma del corpo sui livelli di autostima, o rifiuto di ammettere la gravità della attuale condizione di sottopeso” Il criterio del peso (“al di sotto dell'85% rispetto a quanto previsto”) e l’assenza di mestruazioni (amenorrea) sono altrettanto controversi (ne ho già discusso in passato in altri post, quindi evito di ripetermi).
Questi criteri sarebbero dovuti cambiare nell’ultima edizione del DSM, e nella fattispecie il criterio dell’amenorrea avrebbe dovuto essere eliminato… in realtà, però, leggendo il DSM-V si vede che detti criteri sono rimasti per lo più invariati:
• “Intensa paura di aumentare di peso o di ingrassare, o comportamento persistente che interferisce con l’aumento di peso, nonostante un peso significativamente basso.”
• “Anomalia nel modo in cui è percepito il peso o la forma del proprio corpo; inappropriata influenza del peso o della forma del corpo sulla propria autostima, o persistente perdita della capacità di valutare la gravità della attuale perdita di peso.”
In sostanza, Rieger e i suoi colleghi valutano se questi criteri siano validi (Non esattamente, in effetti, perché quest’articolo è stato pubblicato nel 2001, dunque prima della revisione della corrente edizione del DSM, ma francamente penso che i redattori del DSM avrebbero tratto grosso beneficio dal leggere questo articolo).
Com’era già chiaro dal 1995, quando uno psichiatra inglese, Gerald Russell, scrisse:
“Può darsi che si stia avvicinando il momento in cui sarà opportuno rivedere i nostri criteri diagnostici per l’anoressia nervosa, perché credo ci sia una falsa precisione nella formulazione attuale.” (mia traduzione)
Tra l’altro, Russell è stato il primo a pubblicare una descrizione della bulimia nervosa (e, sì, il “Segno di Russell” ha proprio preso il nome da lui).
Natura delle preoccupazioni per il peso nell’anoressia
Studi cross-culturali suggeriscono che la preoccupazione per il peso è minore nelle pazienti non-occidentali rispetto a quelle occidentali. Per esempio, in uno studio di 70 pazienti cinesi di Hong Kong, meno della metà riportavano preoccupazione per il proprio peso durante la fase più acuta della malattia. Tuttavia, queste donne attribuivano la loro perdita di peso ad inappetenza, epigastralgie o dolori addominali, il che suggerisce che la diagnosi di anoressia nervosa poteva essere del tutto inappropriata: una perdita di peso legata a perdita di appetito (nota bene: nel gergo medico l’ “inappetenza” si traduce con “anoressia” – ma NON “anoressia nervosa”!!) è piuttosto un segno di depressione – non di anoressia nervosa.
Rieger suggerisce che quello che è estremamente comune (universale?) nei casi di anoressia nervosa (“ciò che la distingue da ogni altra condizione patologica”) è la natura egosintonica del disturbo. Più specificatamente, il fatto che “la magrezza estrema non è percepita dalle pazienti come un reale problema: per quanto consapevoli che potrebbero averne dei danni di salute, continuano comunque a perseguirla perché questo le fa stare bene e le fa sentire come se avessero tutto sotto controllo”.
Rieger quota la descrizione di una paziente fatta da Charles Lasègue nel lontano 1873:
“[…] soprattutto, lo stato di quiete, potrei quasi dire uno stato di appagamento davvero patologico. Non solo [la paziente] non mostrava alcun interesse nel farsi curare, ma era sostanzialmente soddisfatta della sua condizione, pur comprendendo i potenziali rischi per la sua salute. Comparando questo stato di soddisfazione con l’ostinazione a proseguire un percorso patologico, non credo che arriverò molto lontano. Comparando invece tutto questo con le altre forme di anoressia, non posso che osservare quale enorme divario vi sia. […]” (mia traduzione)
Nota a margine: la parola “magrezza” NON è contemplata nella prima descrizione dell’anoressia nervosa da parte di Lasègue.
Un’altra interessante paziente la troviamo in uno studio condotto da Ciseaux nel 1980: “[…] è come se [la paziente] non capisse cosa significa prendersi cura della propria salute. Sostiene che più dimagrisce, o comunque si mantiene magra, meglio si sente […] orgogliosa delle proprie capacità di controllo […] come se la restrizione alimentare fosse diventata la cosa più importante che abbia mai fatto nella sua vita. […]” (mia traduzione)
Rieger evidenzia altri esempi di pazienti che non contemplano affatto la paura di prendere peso od ingrassare:
“[…] la restrizione alimentare dà un senso di grande potere, le pazienti provano la sensazione soddisfacente di avere tutto sotto controllo, e questo serve a perpetrare la patologia e a mantenerne la natura egosintonica. […]” (mia traduzione)
Insomma, quello che si evince è che, nelle varie pazienti, la restrizione alimentare e la correlata conseguente perdita di peso viene vissuta come fortemente egosintonica.
Rieger conclude la prima parte dello studio citando Russell:
“La paura di prendere peso sembra essere piuttosto una conseguenza, che non una caratteristica in sé, dell’anoressia nervosa, e non è comunque presente in tutte le pazienti. Quello che invece è costante ed immutabile in tutte le pazienti è il fatto che la natura della patologia è fortemente egosintonica, che è guidata dalla percezione di una sensazione di controllo, e che questo controllo esteso alla propria alimentazione e al proprio corpo permette alle pazienti di venire a capo dei propri conflitti interiori tacitandoli e illudendosi così di averli risolti.” (mia traduzione)
Natura delle preoccupazioni per il peso nell’anoressia in Paesi non-occidentali.
È stato – e tuttora purtroppo è – luogo comune sui DCA il credere che esistano solo nel mondo occidentale, e che la loro comparsa nelle minoranze di immigrati sia legata all’influenza della cultura e dei mass media occidentali: l’internalizzazione di un ideale di magrezza. Alcuni ricercatori avevano provato ad attribuire la differente prevalenza dei DCA nei vari Paesi non-occidentali al diverso “livello di occidentalizzazione” di suddetti Paesi.
Questo tentativo di attribuzione, ovviamente, non tiene conto dei casi di anoressia che comunque si sono verificati ben prima che il modello di magrezza fosse quello dominante nella società. Quel che è certo è che, quando William Gull e Charles Lasègue descrivevano casi di anoressia, la parola “magrezza” non viene MAI menzionata.
Ad oggi esistono studi che mirano a dimostrare che esiste una correlazione tra modelli proposti dalla civiltà occidentale, preoccupazione per la propria fisicità, e DCA, e allo stesso tempo esistono altrettanti studi che mirano a dimostrate che detta correlazione è inesistente.
Per esempio, uno studio rivela che nelle ragazze asiatiche emigrate in Inghilterra, la restrizione alimentare era correlate a valori tradizionali (e NON occidentali) (Hill & Bhatti, 1995). Questa conclusione è supportata da un ulteriore studio condotto da Mumford e i suoi colleghi nel 1991, che rileva la medesima correlazione. Hoek ed i suoi colleghi, in uno studio del 1998, rivelano che la prevalenza dell’anoressia nella popolazione generale di un’isola caraibica era la medesima dei Paesi occidentali, e uno studio di Apter et al. nel 1994 mostra che in un gruppo di villaggi musulmani le donne mostravano le medesime psicopatologie alimentari di pazienti occidentali affette da anoressia.
Fare studi cross-culturali è, tuttavia, molto difficile: innanzitutto, i test e gli strumenti utilizzati per valutare le pazienti in un Paese, sono applicabili, adeguati e rilevanti per pazienti di un altro Paese? E mentre tali problemi metodologici possono spiegare i risultati contraddittori ottenuti, Rieger suggerisce che questo “può essere dovuto ad una possibilità raramente presa in considerazione: che a prescindere dalla provenienza geografica, l’anoressia può rappresentare comunque una strategia di coping che viene messa in atto a prescindere da tutto.”
Gli autori hanno preso in esame anche le cartelle cliniche di 14 pazienti asiatiche affette da anoressia e bulimia, trattate a Sydney, in Australia. Tutte le pazienti riferivano di aver vissuto la restrizione alimentare come egosintonica, ma solo alcune di esse riferivano di aver paura di riprendere peso/ingrassare. Pur non mostrando particolare paura nei confronti del riprendere peso, alcune delle pazienti si rifiutavano di prendere in considerazione la gravità clinica della loro condizione di sottopeso.
Parlando della mia esperienza personale (quanto di meno scientifico possa esserci, insomma…), effettivamente io non ho mai avuto paura di riprendere peso, ed ero anche consapevole del fatto che il mio regime di restrizione alimentare era insalubre ed avrebbe potuto recare danni alla mia salute: tuttavia avevo talmente tanto bisogno di sentirmi in controllo, che le preoccupazioni sulla salute scivolavano in secondo piano. Non mi interessava il peso in sé (tant’è che non mi sono mai pesata, nemmeno nella fase più acuta dell’anoressia), anzi, avrei preferito poter continuare a restringere l’alimentazione pur mantenendo costate il mio peso (cosa impossibile, ovviamente) affinchè nessuno se ne accorgesse e io potessi continuare a restringere l’alimentazione per sentire il senso di controllo che mi trasmetteva. Infatti non m’interessava il perdere peso, mi interessava solo il meccanismo della restrizione alimentare perché mi faceva percepire questo (illusorio) senso di controllo: l’anoressia era una strategia di coping strettamente connessa al mio patologico bisogno di controllare ogni singolo ambito della mia vita. Difatti nel momento in cui, durante il mio percorso di ricovero, sono arrivata a comprendere a pieno questo (inizialmente ne avevo una consapevolezza molto parziale), seguire l’ "equilibrio alimentare" è diventato relativamente semplice.
Tornando allo studio in questione, Rieger e i suoi colleghi lanciano anche dei suggerimenti per studi futuri miranti a valutare la validità dei loro assunti. In sostanza, dicono che i futuri studi dovrebbero essere più esplorativi e aperti alle più svariate interpretazioni. Dicono che dovrebbero andare oltre i soliti test per DCA standardizzati nei Paesi occidentali, e affrontare la tematica con meno pregiudizi lasciando aperto il campo a tutte le ipotesi possibili: valutare per esempio se anche nei Paesi non-occidentali ci siano degli ideali di magrezza su basi culturali o religiose o tradizionali, perché affezionarsi ad ipotesi sbagliate può in definitiva limitare la comprensione dell’anoressia, per cui è importante esaminare criticamente ogni possibile ipotesi.
Per come la vedo io, la domanda centrale è: qual è la caratteristica distintiva dell’anoressia? E’ la paura di prendere peso, e dunque chi non ha questa paura rappresenta un caso “atipico” di anoressia, o è l’ampiamente applicabile criterio dell’egosintonico desiderio di restringere l’alimentazione? Io voto a favore dell’egosintonia: ritengo che l’egosintonica natura della patologia sia ciò che veramente definisce l’anoressia. E, egosintonicamente parlando, suppongo anche di aver ragione.
Se mi rifaccio alla mia esperienza, infatti, io non volevo affatto dimagrire (ero magra già in partenza), anche perché questo comprometteva le mie prestazioni sportive, però volevo restringere l’alimentazione perché mi faceva sentire in controllo. A suo modo, mi faceva stare bene. E io volevo sentirmi in quel modo. Secondo me, queste sono ragioni profondamente egosintoniche, anche perchè non m’interessava il peso in sé.
E voi, ragazze, cosa ne pensate? Qual è stata la vostra esperienza? Quale pensate sia il ruolo della paura di riprendere peso nell’anoressia? E dell’egosintonia? Se vi va, scrivetelo nei commenti!
Etichette:
anoressia,
binge,
bulimia,
cultura,
dca,
DSM,
egosintonia,
magrezza,
no pro ana,
peso,
ricovero,
società,
studi scientifici
venerdì 5 settembre 2014
L'anoressia NON è una questione di peso
Sebbene il termine “anoressia nervosa” stereotipatamente rievochi immagini di adolescenti emaciate, DCA caratterizzati da restrizione alimentare o perdita di peso possono verificarsi – e di fatto si verificano – a qualsiasi peso. Tuttavia, proprio perché l’anoressia è stereotipatamente associata al sottopeso, i medici sono meno propensi a diagnosticarla in ragazze che sono normopeso o sovrappeso, anche se queste hanno tutti gli altri sintomi dell’anoressia.
Ovviamente, ciò crea un problema.
Innanzitutto, non vi è alcuna evidenza clinica che i DCAnas (DCA Non Altrimenti Specificati) – diagnosi che viene ascritta a coloro che non rispondono pienamente a tutti i criteri diagnostici per anoressia e bulimia – siano meno gravi o meno pericolosi della vera e propria anoressia. Come ho scritto in alcuni post precedenti, le persone malate di DCAnas hanno tassi di mortalità comparabili e analoghi livelli di psicopatologia di chi ha l’anoressia o la bulimia.
In uno studio del 2010, Rebecca Peebles ed i suoi colleghi hanno scoperto che “le adolescenti che perdono più del 25% del loro [precedente] peso, ma che sono comunque al di sopra del 90% del peso medio per la loro età, hanno perso una percentuale maggiore del peso corporeo e ad una velocità maggiore, se comparate ad adolescenti affette da anoressia nervosa che hanno un B.M.I. corrispondente ad una condizione di sottopeso”. Inoltre, molto importante, questo studio rivela che le adolescenti in questione “sono molto più medicalmente compromesse delle pazienti che di partenza avevano un peso corporeo inferiore”.
Analogamente, tra le donne adulte, è il delta della variazione di peso (cioè la differenza tra peso attuale e peso più elevato raggiunto) che “corrisponde ai sintomi più severi di anoressia nervosa, e ad una maggiore incidenza di comorbidità con binge, bulimia, depressione, ansia e anomalie mestruali” (Berner et al., 2013).
Da notare che, poiché i DCA in persone normopeso vengono diagnosticati meno frequentemente, o comunque considerati meno gravi, queste persone ne soffrono per un lasso di tempo maggiore prima di ricevere cure appropriate. Questo è particolarmente preoccupante perché la diagnosi precoce e una breve durata della fase acuta del DCA sono i migliori predittori di successo terapeutico e remissioni stabili e durature.
Partendo da queste considerazioni, Jocelyn Lebow e i suoi colleghi (Lebow et al., 2014) hanno deciso di esaminare la prevalenza di normopeso e sovrappeso in adolescenti e donne che hanno chiesto aiuto per un DCA di tipo restrittivo.
Per poterlo fare, hanno esaminato i dati clinici forniti da una clinica specializzata nel trattamento di DCA, ed inerenti tutte le pazienti che vi erano transitate nel giro di 6 anni. Hanno ovviamente escluso dalla ricerca le persone che erano state ricoverate per bulimia o binge (tutte colore che non avevano un regime alimentare prettamente restrittivo, insomma).
Escludendo quindi queste persone, i ricercatori hanno lavorato su 179 pazienti di età compresa tra i 10 e i 20 anni. E dunque, cos’è saltato fuori?
Risultati principali
• Circa il 36% delle ragazze che erano state ricoverate per un comportamento alimentare di tipo prettamente restrittivo erano originariamente sovrappeso. [Mia considerazione collaterale: da notare che dunque circa BEN il 63% delle ragazze ricoverate in conseguenza della restrizione alimentare erano originariamente già normopeso o sottopeso!!]
• Circa la metà delle ragazze originariamente sovrappeso rispondeva completamente ai criteri diagnostici per l’anoressia, l’altra metà era ancora normopeso.
• Non c’erano differenze significative in termini di presenza di amenorrea (assenza di mestruazioni) tra le ragazze in oggetto di studio.
In media, se comparate con la media delle ragazze originariamente già normopeso o sottopeso, le pazienti originariamente sovrappeso:
• Avevano una più lunga storia di malattia prima di chiedere aiuto (20 mesi VS 11 mesi!)
• Avevano perso in valore assoluto più peso rispetto alle altre (un delta di di B.M.I. di 5,4 VS un delta di B.M.I. di 3,6!)
• Avevano la medesima quantità di sintomi fisici
• Avevano la medesima tipologia di sintomi psicologici
E’ importante osservare che, dal momento che questo studio è stato basato su cartelle cliniche di pazienti ricoverate, i dati ottenuti sottostimano la reale incidenza di DCA restrittivi, poiché non considerano tutte quelle persone che vengono seguite ambulatorialmente, e non fanno mai un ricovero in clinica. Inoltre, poiché alle pazienti veniva chiesto di riferire a proposito del peso più alto che avessero mai raggiunto e dei sintomi presentati, non si può avere le certezza che le risposte siano state del tutto e sempre sincere.
In breve, da questo studio si evince che di tutte le persone che chiedono aiuto per un DCA caratterizzato da comportamento alimentare restrittivo, solo circa il 36% era effettivamente sovrappeso originariamente. Anche se queste persone originariamente sovrappeso, al momento della richiesta di aiuto, avevano raggiunto il normopeso, ed erano quindi all’apparenza fisicamente “normali”, presentavano comunque sintomi fisici (per esempio: astenia, intolleranza al freddo, problemi dentali, stipsi, osteoporosi, bradicardia, capelli fragili, lanugo, etc…) e psichici analoghi a quelli delle ragazze sottopeso rispetto al range del B.M.I. o palesemente emaciate.
Implicazioni cliniche
Come gli autori affermano:
“Queste scoperte sottolineano il pericolo di fare una diagnosi di anoressia nervosa basandola principalmente sul peso corporeo, e l’importanza di considerare invece i sintomi fisici e psichici, piuttosto che il peso, come indicatori dello stato di salute di una persona. […] I medici dovrebbero essere capaci di riconoscere una persona affetta da anoressia nervosa a prescindere dal suo B.M.I. […] Eliminando il falso luogo comune che il sovrappeso o il normopeso non possono essere associati ad un DCA prettamente restrittivo come l’anoressia, i medici potrebbero cominciare ad incrementare le diagnosi precoci di DCA nelle pazienti di qualsiasi peso corporeo, senza commettere l’errore di minimizzare il sostanziale impatto negativo sotto ogni punto di vista di questi DCA in pazienti che hanno un peso che pare essere salutare.”
(mia traduzione)
Fortunatamente, pare che nell’ultima edizione del DSM-V sia stato eliminato il criterio del peso in termini assoluti, considerando invece il delta, ovvero l’entità complessiva della perdita di peso. In ogni caso, solo il tempo potrà dirci se queste variazioni potranno permettere di riconoscere meglio DCA restrittivi in pazienti che non risultano essere sottopeso secondo il B.M.I.
Non è peraltro chiaro (almeno, per me non lo è) come i medici potranno applicare queste nuove linee guida (e, peraltro, quanti di loro ne conoscono l’esistenza?). Io credo che un miglioramento della capacità di riconoscere l’anoressia anche in persone non sottopeso non dipenda semplicemente da un aggiornamento delle linee-guida sui DCA, ma soprattutto dalla capacità dei medici di ampliare la loro comprensione di queste malattie e delle persone affette da queste malattie… nonché dal cambiamento della percezione da parte della gente in generale dell’anoressia, cancellando lo stereotipo della falsa equazione che magrezza = anoressia. L’anoressia è una malattia mentale: ergo, se la matrice psicologica è presente, la malattia è tale a qualsiasi peso corporeo.
P.S. = Vi ricordo il "P.S." del post precedente, e ne approfitto per ringraziare le ragazze che hanno già contribuito!... Grazie mille!
Ovviamente, ciò crea un problema.
Innanzitutto, non vi è alcuna evidenza clinica che i DCAnas (DCA Non Altrimenti Specificati) – diagnosi che viene ascritta a coloro che non rispondono pienamente a tutti i criteri diagnostici per anoressia e bulimia – siano meno gravi o meno pericolosi della vera e propria anoressia. Come ho scritto in alcuni post precedenti, le persone malate di DCAnas hanno tassi di mortalità comparabili e analoghi livelli di psicopatologia di chi ha l’anoressia o la bulimia.
In uno studio del 2010, Rebecca Peebles ed i suoi colleghi hanno scoperto che “le adolescenti che perdono più del 25% del loro [precedente] peso, ma che sono comunque al di sopra del 90% del peso medio per la loro età, hanno perso una percentuale maggiore del peso corporeo e ad una velocità maggiore, se comparate ad adolescenti affette da anoressia nervosa che hanno un B.M.I. corrispondente ad una condizione di sottopeso”. Inoltre, molto importante, questo studio rivela che le adolescenti in questione “sono molto più medicalmente compromesse delle pazienti che di partenza avevano un peso corporeo inferiore”.
Analogamente, tra le donne adulte, è il delta della variazione di peso (cioè la differenza tra peso attuale e peso più elevato raggiunto) che “corrisponde ai sintomi più severi di anoressia nervosa, e ad una maggiore incidenza di comorbidità con binge, bulimia, depressione, ansia e anomalie mestruali” (Berner et al., 2013).
Da notare che, poiché i DCA in persone normopeso vengono diagnosticati meno frequentemente, o comunque considerati meno gravi, queste persone ne soffrono per un lasso di tempo maggiore prima di ricevere cure appropriate. Questo è particolarmente preoccupante perché la diagnosi precoce e una breve durata della fase acuta del DCA sono i migliori predittori di successo terapeutico e remissioni stabili e durature.
Partendo da queste considerazioni, Jocelyn Lebow e i suoi colleghi (Lebow et al., 2014) hanno deciso di esaminare la prevalenza di normopeso e sovrappeso in adolescenti e donne che hanno chiesto aiuto per un DCA di tipo restrittivo.
Per poterlo fare, hanno esaminato i dati clinici forniti da una clinica specializzata nel trattamento di DCA, ed inerenti tutte le pazienti che vi erano transitate nel giro di 6 anni. Hanno ovviamente escluso dalla ricerca le persone che erano state ricoverate per bulimia o binge (tutte colore che non avevano un regime alimentare prettamente restrittivo, insomma).
Escludendo quindi queste persone, i ricercatori hanno lavorato su 179 pazienti di età compresa tra i 10 e i 20 anni. E dunque, cos’è saltato fuori?
Risultati principali
• Circa il 36% delle ragazze che erano state ricoverate per un comportamento alimentare di tipo prettamente restrittivo erano originariamente sovrappeso. [Mia considerazione collaterale: da notare che dunque circa BEN il 63% delle ragazze ricoverate in conseguenza della restrizione alimentare erano originariamente già normopeso o sottopeso!!]
• Circa la metà delle ragazze originariamente sovrappeso rispondeva completamente ai criteri diagnostici per l’anoressia, l’altra metà era ancora normopeso.
• Non c’erano differenze significative in termini di presenza di amenorrea (assenza di mestruazioni) tra le ragazze in oggetto di studio.
In media, se comparate con la media delle ragazze originariamente già normopeso o sottopeso, le pazienti originariamente sovrappeso:
• Avevano una più lunga storia di malattia prima di chiedere aiuto (20 mesi VS 11 mesi!)
• Avevano perso in valore assoluto più peso rispetto alle altre (un delta di di B.M.I. di 5,4 VS un delta di B.M.I. di 3,6!)
• Avevano la medesima quantità di sintomi fisici
• Avevano la medesima tipologia di sintomi psicologici
E’ importante osservare che, dal momento che questo studio è stato basato su cartelle cliniche di pazienti ricoverate, i dati ottenuti sottostimano la reale incidenza di DCA restrittivi, poiché non considerano tutte quelle persone che vengono seguite ambulatorialmente, e non fanno mai un ricovero in clinica. Inoltre, poiché alle pazienti veniva chiesto di riferire a proposito del peso più alto che avessero mai raggiunto e dei sintomi presentati, non si può avere le certezza che le risposte siano state del tutto e sempre sincere.
In breve, da questo studio si evince che di tutte le persone che chiedono aiuto per un DCA caratterizzato da comportamento alimentare restrittivo, solo circa il 36% era effettivamente sovrappeso originariamente. Anche se queste persone originariamente sovrappeso, al momento della richiesta di aiuto, avevano raggiunto il normopeso, ed erano quindi all’apparenza fisicamente “normali”, presentavano comunque sintomi fisici (per esempio: astenia, intolleranza al freddo, problemi dentali, stipsi, osteoporosi, bradicardia, capelli fragili, lanugo, etc…) e psichici analoghi a quelli delle ragazze sottopeso rispetto al range del B.M.I. o palesemente emaciate.
Implicazioni cliniche
Come gli autori affermano:
“Queste scoperte sottolineano il pericolo di fare una diagnosi di anoressia nervosa basandola principalmente sul peso corporeo, e l’importanza di considerare invece i sintomi fisici e psichici, piuttosto che il peso, come indicatori dello stato di salute di una persona. […] I medici dovrebbero essere capaci di riconoscere una persona affetta da anoressia nervosa a prescindere dal suo B.M.I. […] Eliminando il falso luogo comune che il sovrappeso o il normopeso non possono essere associati ad un DCA prettamente restrittivo come l’anoressia, i medici potrebbero cominciare ad incrementare le diagnosi precoci di DCA nelle pazienti di qualsiasi peso corporeo, senza commettere l’errore di minimizzare il sostanziale impatto negativo sotto ogni punto di vista di questi DCA in pazienti che hanno un peso che pare essere salutare.”
(mia traduzione)
Fortunatamente, pare che nell’ultima edizione del DSM-V sia stato eliminato il criterio del peso in termini assoluti, considerando invece il delta, ovvero l’entità complessiva della perdita di peso. In ogni caso, solo il tempo potrà dirci se queste variazioni potranno permettere di riconoscere meglio DCA restrittivi in pazienti che non risultano essere sottopeso secondo il B.M.I.
Non è peraltro chiaro (almeno, per me non lo è) come i medici potranno applicare queste nuove linee guida (e, peraltro, quanti di loro ne conoscono l’esistenza?). Io credo che un miglioramento della capacità di riconoscere l’anoressia anche in persone non sottopeso non dipenda semplicemente da un aggiornamento delle linee-guida sui DCA, ma soprattutto dalla capacità dei medici di ampliare la loro comprensione di queste malattie e delle persone affette da queste malattie… nonché dal cambiamento della percezione da parte della gente in generale dell’anoressia, cancellando lo stereotipo della falsa equazione che magrezza = anoressia. L’anoressia è una malattia mentale: ergo, se la matrice psicologica è presente, la malattia è tale a qualsiasi peso corporeo.
P.S. = Vi ricordo il "P.S." del post precedente, e ne approfitto per ringraziare le ragazze che hanno già contribuito!... Grazie mille!
venerdì 11 aprile 2014
Scendere dalla bilancia: Markers di gravità dell'anoressia non basati sul peso
Penso che chiunque abbia un DCA sia perfettamente consapevole che la propria patologia poggia su basi che hanno poco e niente a che vedere col cibo e con la magrezza, ma che sono essenzialmente rappresentate dalle soggettive problematiche presenti in ciascuna persona affetta da DCA. Sebbene sia perciò grande la nostra voglia di gridare: “Il peso non c’entra una mazza, è solo un mero capro espiatorio, i veri problemi sono ben altri e più profondi!”, è un dato di fatto che, in molti casi, il trattamento dei DCA è basato principalmente sul peso corporeo. Questo è tanto più vero in Paesi come gli Stati Uniti d’America dove la sanità è privata e, addirittura, le persone malate di DCA possono accedere alle cliniche specializzate solo se il loro B.M.I. è inferiore a 18 o superiore a 25. Per quelle ragazze che, pur avendo un DCA con tutti i crismi, si mantengono nel range del normopeso… niente posto in clinica!
Ora, penso che siamo tutte d’accordo nel ritenere che, da questo punto di vista, il Sistema Sanitario Privato degli U.S.A. è veramente marcio. Però, nel fare così, propaganda un’idea che credo non sarà ignota a nessuna di voi: l’idea che se non siete gravemente sottopeso, allora non siete “abbastanza malate” da chiedere aiuto. Idea che, ovviamente, reputo SBAGLIATISSIMA. Non fraintendetemi, non sto dicendo che il peso corporeo sia una fattore di rischio irrilevante nel valutare un DCA (è un dato di fatto scientificamente comprovato che più il B.M.I. è basso, maggiore è il rischio di morire… ma questo non significa che, se il B.M.I. è nel range del normopeso, allora questo rischio è scongiurato!), ma ci sono millemila problematiche fisiche e psicologiche legate ai DCA che rappresentano altrettanti fattori di rischio e potenziali cause di morte anche per persone che hanno un B.M.I. non particolarmente basso.
Questo detto, immaginatevi qual è stata la mia sorpresa quando ho scoperto che, nell’imminente DSM-V, il principale marker di gravità per l’anoressia è… rullo di tamburi… il B.M.I.!!
Cioè, seriamente?
Seriamente.
La bulimia e il binge, in questa nuova edizione del DSM, hanno dei marker di gravità che sono prettamente comportamentali: per esempio, il numero di abbuffate, o il numero di episodi di vomito autoindotto per settimana. È pur vero che, anche nel DSM-IV-TR, i criteri diagnostici di queste due patologie non fanno menzione alle variazioni di peso come invece succede per l’anoressia, ma tant’è.
Ripeto: non penso che il peso, e la perdita di peso, siano irrilevanti nell’anoressia (certo che non lo sono!), ma da qui a dire che sono l’unico marker di gravità dell’anoressia, ne corre di acqua sotto ai ponti! E mi sembra una valutazione estremamente miope, tra l’altro. Fortunatamente, non sono l’unica a pensarla così. Un ampio gruppo di ricercatori ha recentemente pubblicato un articolo su “International Journal of Eating Disorders”, che dimostra come i comportamenti alimentari restrittivi siano un marker indipendente dalla gravità dell’anoressia. (De Young, et al.; 2013).
Per realizzare lo studio su cui è basato l’articolo, i ricercatori hanno reclutato 118 donne cui era stata diagnosticata l’anoressia, e che erano state seguite ambulatorialmente nel Midwest. Queste donne sono state poi suddivise in 2 sottogruppi: il primo comprendente le donne con anoressia di tipo restrittivo (sottotipo 1), il secondo comprendente le donne con anoressia associata a abbuffate/condotte di eliminazione (sottotipo 2).
Alle donne facenti parte dello studio è stato chiesto dai ricercatori quali comportamenti tipici del loro sottotipo di anoressia stessero utilizzando, od avessero utilizzato recentemente, e quanto tempo mentale fosse riversato sul DCA. Il primo risultato di queste interviste è stato rappresentato dall’osservazione che le donne appartenenti al sottogruppo di anoressia con abbuffate/condotte di eliminazione sono quelle con più pensieri ossessivi nei confronti dell’alimentazione, e con più comportamenti disturbati; il che è in linea con i risultati ottenuti in altri precedenti studi simili.
Tuttavia, da questo studio sono stati tratti altri risultati decisamente interessanti.
Le persone affette da anoressia con abbuffate/condotte di eliminazione, pur avendo un B.M.I. tendenzialmente superiore rispetto a quello delle donne affette da anoressia restrittiva, presentavano dei marker decisamente differenti per quel che concerne la gravità del DCA. Il primo gruppo, infatti, presentava:
• un numero maggiore di episodi di abbuffate e condotte di eliminazione per settimana (il che, okay, è ovvio, visto che chi ha un’anoressia di tipo prettamente restrittivo non ha affatto episodi di abbuffate nè condotte di eliminazione.);
• più momenti di digiuno completo;
• più pasti saltati a piè pari;
• maggiore entità di restrizione alimentare ad ogni pasto;
• maggiore dichiarazione di volontà di “mangiare il meno possibile”;
• maggior tempo dedicato ai pensieri ossessivi tipici dell’anoressia;
• maggiori livelli di ansia.
Peraltro, questi comportamenti non venivano riferiti come necessariamente conseguenti ad un’abbuffata (ci sono degli studi che dimostrano che più è repentina e di maggiore entità la restrizione alimentare, più è facile cadere nell’abbuffata), e che, di conseguenza, aggravavano le condizioni fisiche della persona, e dunque erano markers di gravità del DCA, indipendentemente dal peso della persona. In effetti, erano proprio le donne con i valori di B.M.I. più elevati ad avere una maggior quantità di pensieri ossessivi, a digiunare di più, ad abbuffarsi per poi provocarsi il vomito di più, ad avere più pensieri ossessivi e dunque ad essere, in definitiva, molto più preda del DCA, il che ovviamente configura di fatto una situazione di gravità della patologia maggiore.
Gli autori dello studio concludono:
“Per l’anoressia, generalmente il marker di gravità di patologia più utilizzato è il B.M.I..Il peso corporeo è un marker indiscutibile in merito alla gravità da un punto di vista prettamente medico-fisico dell’anoressia, anche perché è strettamente associato con il rischio di mortalità. I risultati di questo studio, tuttavia, indicano che i due sottotipi di anoressia presentano markers di gravità differenti, e che si distaccano dal peso in sé per sé: markers che vanno a valutare i sintomi comportamentali. Ebbene, è proprio la frequenza di questi comportamenti patologici, che può rappresentare un marker di gravità dell’anoressia, indipendentemente dal B.M.I. [...] I professionisti che lavorano clinicamente con le persone affette da anoressia potrebbero dunque valutare e monitorare la varietà di comportamenti con cui le loro pazienti si approcciano all’alimentazione, nonché l’entità e l’ossessività dei pensieri propri del DCA, notando così che la configurazione di questi comportamenti e di questi pensieri può variare a seconda sottotipo e rappresentare un marker di gravità dell’anoressia non basato sul peso.”
(mia traduzione)
Con questo, non voglio dire che il peso corporeo non possa essere considerato come un marker di gravità per l’anoressia, ci mancherebbe altro, però voglio dire che NON DEVE essere considerato come L’UNICO marker. Dire che la gravità dell’anoressia si basa solo su quanto pesa la persona malata, corrisponde al giudicare la gravità di una malattia mentale basandosi su criteri somatici. È una contraddizione in termini, mi sembra ovvio. Nessuno penserebbe mai di fare una cosa del genere per altre malattie mentali come la depressione o l’ansia generalizzata. Per cui, a mio parere, sarebbe molto importante porre l’accento su quelli che sono gli aspetti comportamentali e i pensieri ossessivi tipici del DCA per valutare l’effettiva gravità dell’anoressia, perché queste sono cose che hanno un enorme impatto nella vita quotidiana della persona, e dunque sono importantissimi determinanti della qualità della vita. E questo indipendentemente dal peso. Perciò, è su questi nuovi marker, più che su peso, che dovemmo concentrarci per valutare la gravità dell’anoressia, e per fornire così alla ragazza malata il livello e la tipologia di cure di cui necessita.
Ora, penso che siamo tutte d’accordo nel ritenere che, da questo punto di vista, il Sistema Sanitario Privato degli U.S.A. è veramente marcio. Però, nel fare così, propaganda un’idea che credo non sarà ignota a nessuna di voi: l’idea che se non siete gravemente sottopeso, allora non siete “abbastanza malate” da chiedere aiuto. Idea che, ovviamente, reputo SBAGLIATISSIMA. Non fraintendetemi, non sto dicendo che il peso corporeo sia una fattore di rischio irrilevante nel valutare un DCA (è un dato di fatto scientificamente comprovato che più il B.M.I. è basso, maggiore è il rischio di morire… ma questo non significa che, se il B.M.I. è nel range del normopeso, allora questo rischio è scongiurato!), ma ci sono millemila problematiche fisiche e psicologiche legate ai DCA che rappresentano altrettanti fattori di rischio e potenziali cause di morte anche per persone che hanno un B.M.I. non particolarmente basso.
Questo detto, immaginatevi qual è stata la mia sorpresa quando ho scoperto che, nell’imminente DSM-V, il principale marker di gravità per l’anoressia è… rullo di tamburi… il B.M.I.!!
Cioè, seriamente?
Seriamente.
La bulimia e il binge, in questa nuova edizione del DSM, hanno dei marker di gravità che sono prettamente comportamentali: per esempio, il numero di abbuffate, o il numero di episodi di vomito autoindotto per settimana. È pur vero che, anche nel DSM-IV-TR, i criteri diagnostici di queste due patologie non fanno menzione alle variazioni di peso come invece succede per l’anoressia, ma tant’è.
Ripeto: non penso che il peso, e la perdita di peso, siano irrilevanti nell’anoressia (certo che non lo sono!), ma da qui a dire che sono l’unico marker di gravità dell’anoressia, ne corre di acqua sotto ai ponti! E mi sembra una valutazione estremamente miope, tra l’altro. Fortunatamente, non sono l’unica a pensarla così. Un ampio gruppo di ricercatori ha recentemente pubblicato un articolo su “International Journal of Eating Disorders”, che dimostra come i comportamenti alimentari restrittivi siano un marker indipendente dalla gravità dell’anoressia. (De Young, et al.; 2013).
Per realizzare lo studio su cui è basato l’articolo, i ricercatori hanno reclutato 118 donne cui era stata diagnosticata l’anoressia, e che erano state seguite ambulatorialmente nel Midwest. Queste donne sono state poi suddivise in 2 sottogruppi: il primo comprendente le donne con anoressia di tipo restrittivo (sottotipo 1), il secondo comprendente le donne con anoressia associata a abbuffate/condotte di eliminazione (sottotipo 2).
Alle donne facenti parte dello studio è stato chiesto dai ricercatori quali comportamenti tipici del loro sottotipo di anoressia stessero utilizzando, od avessero utilizzato recentemente, e quanto tempo mentale fosse riversato sul DCA. Il primo risultato di queste interviste è stato rappresentato dall’osservazione che le donne appartenenti al sottogruppo di anoressia con abbuffate/condotte di eliminazione sono quelle con più pensieri ossessivi nei confronti dell’alimentazione, e con più comportamenti disturbati; il che è in linea con i risultati ottenuti in altri precedenti studi simili.
Tuttavia, da questo studio sono stati tratti altri risultati decisamente interessanti.
Le persone affette da anoressia con abbuffate/condotte di eliminazione, pur avendo un B.M.I. tendenzialmente superiore rispetto a quello delle donne affette da anoressia restrittiva, presentavano dei marker decisamente differenti per quel che concerne la gravità del DCA. Il primo gruppo, infatti, presentava:
• un numero maggiore di episodi di abbuffate e condotte di eliminazione per settimana (il che, okay, è ovvio, visto che chi ha un’anoressia di tipo prettamente restrittivo non ha affatto episodi di abbuffate nè condotte di eliminazione.);
• più momenti di digiuno completo;
• più pasti saltati a piè pari;
• maggiore entità di restrizione alimentare ad ogni pasto;
• maggiore dichiarazione di volontà di “mangiare il meno possibile”;
• maggior tempo dedicato ai pensieri ossessivi tipici dell’anoressia;
• maggiori livelli di ansia.
Peraltro, questi comportamenti non venivano riferiti come necessariamente conseguenti ad un’abbuffata (ci sono degli studi che dimostrano che più è repentina e di maggiore entità la restrizione alimentare, più è facile cadere nell’abbuffata), e che, di conseguenza, aggravavano le condizioni fisiche della persona, e dunque erano markers di gravità del DCA, indipendentemente dal peso della persona. In effetti, erano proprio le donne con i valori di B.M.I. più elevati ad avere una maggior quantità di pensieri ossessivi, a digiunare di più, ad abbuffarsi per poi provocarsi il vomito di più, ad avere più pensieri ossessivi e dunque ad essere, in definitiva, molto più preda del DCA, il che ovviamente configura di fatto una situazione di gravità della patologia maggiore.
Gli autori dello studio concludono:
“Per l’anoressia, generalmente il marker di gravità di patologia più utilizzato è il B.M.I..Il peso corporeo è un marker indiscutibile in merito alla gravità da un punto di vista prettamente medico-fisico dell’anoressia, anche perché è strettamente associato con il rischio di mortalità. I risultati di questo studio, tuttavia, indicano che i due sottotipi di anoressia presentano markers di gravità differenti, e che si distaccano dal peso in sé per sé: markers che vanno a valutare i sintomi comportamentali. Ebbene, è proprio la frequenza di questi comportamenti patologici, che può rappresentare un marker di gravità dell’anoressia, indipendentemente dal B.M.I. [...] I professionisti che lavorano clinicamente con le persone affette da anoressia potrebbero dunque valutare e monitorare la varietà di comportamenti con cui le loro pazienti si approcciano all’alimentazione, nonché l’entità e l’ossessività dei pensieri propri del DCA, notando così che la configurazione di questi comportamenti e di questi pensieri può variare a seconda sottotipo e rappresentare un marker di gravità dell’anoressia non basato sul peso.”
(mia traduzione)
Con questo, non voglio dire che il peso corporeo non possa essere considerato come un marker di gravità per l’anoressia, ci mancherebbe altro, però voglio dire che NON DEVE essere considerato come L’UNICO marker. Dire che la gravità dell’anoressia si basa solo su quanto pesa la persona malata, corrisponde al giudicare la gravità di una malattia mentale basandosi su criteri somatici. È una contraddizione in termini, mi sembra ovvio. Nessuno penserebbe mai di fare una cosa del genere per altre malattie mentali come la depressione o l’ansia generalizzata. Per cui, a mio parere, sarebbe molto importante porre l’accento su quelli che sono gli aspetti comportamentali e i pensieri ossessivi tipici del DCA per valutare l’effettiva gravità dell’anoressia, perché queste sono cose che hanno un enorme impatto nella vita quotidiana della persona, e dunque sono importantissimi determinanti della qualità della vita. E questo indipendentemente dal peso. Perciò, è su questi nuovi marker, più che su peso, che dovemmo concentrarci per valutare la gravità dell’anoressia, e per fornire così alla ragazza malata il livello e la tipologia di cure di cui necessita.
venerdì 1 novembre 2013
Lasciar andare l'idea del "peso corporeo ideale"
(Premessa: quanto segue deriva in parte dai miei studi, ma in altra parte dai miei ragionamenti e dalla mia opinione personale. Sono assolutamente convinta di ciò che scrivo in merito alla mia opinione, ma questo non la rende comunque ovviamente verità assoluta.)
Leggendo qualsiasi cosa riguardi i DCA – soprattutto l’anoressia – dagli studi scientifici alla letteratura, sembra impossibile riuscire ad evitare le frasi “peso corporeo ideale” e “peso corporeo previsto”. Spesso e volentieri i pesi sono espressi in percentuale rispetto al peso corporeo ideale/previsto. Lo stesso DSM pone come criterio diagnostico per l’anoressia: “peso corporeo al di sotto dell'85% rispetto a quanto previsto”. E anche l’efficacia dei trattamenti viene valutata sulla capacità di ritornare all’ 85%/90%/95% (scegliete quello che preferite) del peso corporeo ideale/previsto.
Posso essere molto terra-terra? “Peso corporeo ideale/previsto” è una frase che DETESTO.
In molti studi i ricercatori calcolano il “peso corporeo ideale” sulla base del 50° percentile del B.M.I. rispetto all’età. Avete presente i percentili su cui si valuta la crescita dei neonati? Ecco, sostanzialmente la stessa cosa. Data una certa età di una persona, e data la sua altezza, è possibile calcolare il “peso corporeo ideale” di un individuo. Questo “peso corporeo ideale” viene spesso considerato il peso che chi è affetta da un DCA dovrebbe raggiungere… perché, cavolo, lo dice il nome stesso che è “ideale”!!
Okay, allora, ragioniamoci un attimo su. Il 50° percentile per il peso o per il B.M.I. è in realtà “ideale” solo per quell’ 1% della popolazione che fisiologicamente, naturalmente, senza aver mai avuto un DCA né problemi di alcun tipo con l’alimentazione, cade su quel percentile. Per il restante 99% della popolazione, il 50° percentile rappresenta una sovra o una sottostima del proprio peso.
Ora, so benissimo che viene fatto un sacco di lavoro da parte dei medici quando si tratta di definire appropriati obiettivi di recupero del peso corporeo per una persona che ha un DCA, e stimare che una persona debba raggiungere il 50° percentile di peso (rispetto alla sua età e alla sua altezza) può essere un punto di partenza non del tutto negativo, in mancanza di altri dati… Ma possiamo almeno ammettere che questa è solo una stima generica, e non un “ideale”?!
Tanto più che il “peso corporeo ideale” corrisponde ad una cifra. Ad un numero ben preciso. Il che è stupido. Basti pensare al fatto che il peso di una qualsiasi donna può variare da alcuni etti finanche ad alcuni chili durante il ciclo mestruale. Inoltre, il peso corporeo di una qualsiasi persona (uomo o donna che sia) può variare in base allo stato di idratazione, al periodo dell’anno, all’assetto ormonale, alla vicinanza dall’ultimo pasto rispetto alla pesata, al fatto di aver svuotato o meno vescica ed intestino… e un sacco di altre cose.
Parlando con alcune ragazze che sono state ricoverate in una clinica specializzata nel trattamento per DCA (della quale non faccio il nome per ovvi motivi), mi è stato detto che al momento del ricovero veniva assegnato loro un “peso corporeo ideale” da raggiungere: quello corrispondente, in funzione della loro altezza, ad un B.M.I. = 19. Cioè, seriamente?? E io che pensavo che fossero le persone con un DCA quelle fissate con il controllo di tutto, oppure quelle fissate con gli obiettivi di peso e di B.M.I. da raggiungere… e pensavo che, viceversa, il compito di una clinica fosse quello di permettere alla persona di fare introspezione e di sviscerare le sue vere problematiche, svincolandosi e mettendo in secondo piano cibo e peso… E invece mi sbagliavo, a quanto pare non solo chi ha un DCA, ma anche alcune cliniche si focalizzano su numeri, peso e B.M.I..
Commento soltanto: BAH.
Inoltre, quando si parla di qualcosa come il “peso corporeo ideale”, trovo veramente ironico l’utilizzo della parola “ideale”. Perché, di quale “ideale” siamo parlando, esattamente? Gli ideali culturali? (Ma non fatemi ridere…) Gli ideali matematici? Gli ideali statistici? Gli ideali di salute? Forse. Ma, nuovamente, non esiste un peso specifico e ben preciso che corrisponde alla “salute”. Ogni persona ha un certo range di peso che per lei può essere comunque considerato associato ad uno stato di salute “ideale”.
Una volta una psichiatra con cui avevo da poco intrapreso un percorso psicoterapeutico mi propose di impostare il mio obiettivo di peso da raggiungere (poiché in quel periodo ero piuttosto sottopeso, in quanto reduce da una ricaduta) chiedendo a me quanto volessi pesare, quale peso fossi stata disposta a raggiungere, considerandolo come se fosse il mio “peso corporeo ideale”. Hmmm, chiedere ad una persona affetta da anoressia restrittiva quanto vorrebbe idealmente pesare mi sembra quantomeno miope, per non dire di peggio. (Per la cronaca: ovviamente mollai questa psicoterapia dopo il quarto incontro o giù di lì.)
Un altro genio assoluto (una nutrizionista, nella fattispecie) era convinta che il “peso corporeo ideale” che avrei dovuto raggiungere era quello previsto dal B.M.I., per cui il target sarebbe stato quello di raggiungere un valore di B.M.I. almeno pari a 18,5. (Sì, ho mollato anche questa nutrizionista, naturalmente.) Certamente il B.M.I. può essere considerato un buon range nella valutazione del peso corporeo, perchè ci sono studi scientifici che dimostrano che le persone che hanno una maggiore aspettativa di vita e una minore incidenza delle malattie, sono effettivamente quelle che hanno un B.M.I. compreso tra 18,5 e 25. Ma questo non è comunque un assoluto, è solo una statistica, e il peso del singolo non risponde alla statistica, bensì risponde al proprio patrimonio genetico. Il set-point di peso corporeo è una cosa assolutamente individualizzata, e sebbene in molti casi cada in quello che il B.M.I. definisce “normopeso”, nulla vita che possa cadere anche sopra o sotto questo range, e che la persona sia comunque in salute, perché è fisiologicamente geneticamente settata su un peso al di fuori del normopeso stimato col B.M.I..
Inoltre, quando si fa una valutazione sul peso di una persona che ha un DCA, credo sia di fatto estremamente difficile determinare quale sia il “peso corporeo ideale” che essa dovrebbe raggiungere. Può infatti sorgere spontaneo il pensiero: il mio “peso corporeo ideale” è quello che avevo prima di ammalarmi di anoressia. Okay… ma questo è solo parzialmente vero. Perché se una ragazza si ammala di anoressia a 10 anni, avrebbe ancora un bel po’ di sviluppo da fare… e – annuncio di pubblico servizio – non è generalmente salutare per una donna pesare quanto pesava quando era una 10enne. Poi, certo, se una si ammala a 25 anni, allora il discorso del tornare al peso precedente alla malattia ha un senso… ma occorre non farci fuorviare da questa considerazione.
Il problema è che l’idea di “peso corporeo ideale” è veicolata da un enorme bagaglio culturale. Fortunatamente, ultimamente mi è capitato di leggere su Internet che ci sono diversi professionisti nel campo dei DCA che cercano di spiegare e di far passare l’idea che si può essere in salute anche se si indossano taglie diverse, che c’è più da puntare sulla terapia degli aspetti mentali dell’anoressia, e non limitarsi a valutare solamente l’aspetto della rialmentazione… e questo mi dà un po’ di speranza, perché vedo che c’è gente che finalmente apre gli occhi.
E dunque, se non usiamo “peso corporeo ideale”, qual è l’alternativa? Peso target? Forse… ma per le adolescenti, in pieno periodo di crescita e sviluppo, i target non sono stazionari. Perciò, penso che dovremo lasciar andare l’idea di “peso corporeo ideale/previsto”, e focalizzarsi invece (oltre che, ovviamente, sugli aspetti mentali della malattia) su qual è il set-point di peso biologico di ciascuna paziente. Fare un discorso assolutamente individualizzato, lasciando perdere le generalizzazioni. Ognuna di noi discende da una certa famiglia, ha la propria genetica, il proprio morfotipo, le proprie peculiarità costituzionali. Ogni persona ha un suo proprio range di peso corporeo che è biologicamente appropriato per lei stessa. Niente a che vedere con i target o con l’idealità, bensì con la genetica, la biologia, e il set-point di ciascuna di noi. Questa è la realtà.
Occorre smetterla di pensare che esista un valore univoco di B.M.I. che definisce lo stato di salute o il “peso corporeo ideale” delle persone. Occorre smetterla di pensare che essere sottopeso sia solo e soltanto sinonimo di avere un B.M.I. < 18,5. Non è così. Ognuna di noi ha il suo set-point fisiologico di peso corporeo, un suo proprio range di “normalità”: si è sottopeso se si scende al disotto di quel proprio ed individuale range. Ma questo range non necessariamente corrisponde a quello del B.M.I.. Per quanto la maggior parte delle persone abbia effettivamente un set-point fisiologico ascrivibile ad un B.M.I. compreso tra 18,5 e 25, ci sono alcune persone che per stare bene hanno bisogno di un peso che corrisponde ad un B.M.I. > 25, e alcune altre persone che sono perfettamente in salute pur con un B.M.I. < 18,5. È la variabilità interindividuale, quella che non può essere assoggettata a nessuna statistica. Per cui, se per esempio c’è una ragazza il cui set-point di peso fisiologico corrisponde ad un B.M.I. = 26, e poi il suo peso cala fino ad arrivare ad un B.M.I. = 23, la statistica dice che è meglio, perché la ragazza è passata da un sovrappeso ad un normopeso… ma, in realtà, rispetto al suo standard fisiologico, la ragazza in questione non è normopeso, bensì sottopeso! E, per lei, quella non rappresenta perciò una situazione di salute. Ragionare per numeri aiuta senz’altro a schematizzare, ma non dimentichiamo che le statistiche non possono trascendere l’individualità. Dobbiamo dunque essere consapevoli del fatto che alcune persone hanno set-point di peso biologicamente appropriati che sono anche al di sopra di B.M.I. = 25, o al di sotto di B.M.I. = 18,5. E va bene così.
In un mondo di circa 7 miliardi d’individui, non esiste alcun assoluto “peso corporeo ideale”. È un qualcosa di assolutamente variabile e soggettivo. Prima accetteremo questo dato di fatto, meglio staremo tutti quanti.
Leggendo qualsiasi cosa riguardi i DCA – soprattutto l’anoressia – dagli studi scientifici alla letteratura, sembra impossibile riuscire ad evitare le frasi “peso corporeo ideale” e “peso corporeo previsto”. Spesso e volentieri i pesi sono espressi in percentuale rispetto al peso corporeo ideale/previsto. Lo stesso DSM pone come criterio diagnostico per l’anoressia: “peso corporeo al di sotto dell'85% rispetto a quanto previsto”. E anche l’efficacia dei trattamenti viene valutata sulla capacità di ritornare all’ 85%/90%/95% (scegliete quello che preferite) del peso corporeo ideale/previsto.
Posso essere molto terra-terra? “Peso corporeo ideale/previsto” è una frase che DETESTO.
In molti studi i ricercatori calcolano il “peso corporeo ideale” sulla base del 50° percentile del B.M.I. rispetto all’età. Avete presente i percentili su cui si valuta la crescita dei neonati? Ecco, sostanzialmente la stessa cosa. Data una certa età di una persona, e data la sua altezza, è possibile calcolare il “peso corporeo ideale” di un individuo. Questo “peso corporeo ideale” viene spesso considerato il peso che chi è affetta da un DCA dovrebbe raggiungere… perché, cavolo, lo dice il nome stesso che è “ideale”!!
Okay, allora, ragioniamoci un attimo su. Il 50° percentile per il peso o per il B.M.I. è in realtà “ideale” solo per quell’ 1% della popolazione che fisiologicamente, naturalmente, senza aver mai avuto un DCA né problemi di alcun tipo con l’alimentazione, cade su quel percentile. Per il restante 99% della popolazione, il 50° percentile rappresenta una sovra o una sottostima del proprio peso.
Ora, so benissimo che viene fatto un sacco di lavoro da parte dei medici quando si tratta di definire appropriati obiettivi di recupero del peso corporeo per una persona che ha un DCA, e stimare che una persona debba raggiungere il 50° percentile di peso (rispetto alla sua età e alla sua altezza) può essere un punto di partenza non del tutto negativo, in mancanza di altri dati… Ma possiamo almeno ammettere che questa è solo una stima generica, e non un “ideale”?!
Tanto più che il “peso corporeo ideale” corrisponde ad una cifra. Ad un numero ben preciso. Il che è stupido. Basti pensare al fatto che il peso di una qualsiasi donna può variare da alcuni etti finanche ad alcuni chili durante il ciclo mestruale. Inoltre, il peso corporeo di una qualsiasi persona (uomo o donna che sia) può variare in base allo stato di idratazione, al periodo dell’anno, all’assetto ormonale, alla vicinanza dall’ultimo pasto rispetto alla pesata, al fatto di aver svuotato o meno vescica ed intestino… e un sacco di altre cose.
Parlando con alcune ragazze che sono state ricoverate in una clinica specializzata nel trattamento per DCA (della quale non faccio il nome per ovvi motivi), mi è stato detto che al momento del ricovero veniva assegnato loro un “peso corporeo ideale” da raggiungere: quello corrispondente, in funzione della loro altezza, ad un B.M.I. = 19. Cioè, seriamente?? E io che pensavo che fossero le persone con un DCA quelle fissate con il controllo di tutto, oppure quelle fissate con gli obiettivi di peso e di B.M.I. da raggiungere… e pensavo che, viceversa, il compito di una clinica fosse quello di permettere alla persona di fare introspezione e di sviscerare le sue vere problematiche, svincolandosi e mettendo in secondo piano cibo e peso… E invece mi sbagliavo, a quanto pare non solo chi ha un DCA, ma anche alcune cliniche si focalizzano su numeri, peso e B.M.I..
Commento soltanto: BAH.
Inoltre, quando si parla di qualcosa come il “peso corporeo ideale”, trovo veramente ironico l’utilizzo della parola “ideale”. Perché, di quale “ideale” siamo parlando, esattamente? Gli ideali culturali? (Ma non fatemi ridere…) Gli ideali matematici? Gli ideali statistici? Gli ideali di salute? Forse. Ma, nuovamente, non esiste un peso specifico e ben preciso che corrisponde alla “salute”. Ogni persona ha un certo range di peso che per lei può essere comunque considerato associato ad uno stato di salute “ideale”.
Una volta una psichiatra con cui avevo da poco intrapreso un percorso psicoterapeutico mi propose di impostare il mio obiettivo di peso da raggiungere (poiché in quel periodo ero piuttosto sottopeso, in quanto reduce da una ricaduta) chiedendo a me quanto volessi pesare, quale peso fossi stata disposta a raggiungere, considerandolo come se fosse il mio “peso corporeo ideale”. Hmmm, chiedere ad una persona affetta da anoressia restrittiva quanto vorrebbe idealmente pesare mi sembra quantomeno miope, per non dire di peggio. (Per la cronaca: ovviamente mollai questa psicoterapia dopo il quarto incontro o giù di lì.)
Un altro genio assoluto (una nutrizionista, nella fattispecie) era convinta che il “peso corporeo ideale” che avrei dovuto raggiungere era quello previsto dal B.M.I., per cui il target sarebbe stato quello di raggiungere un valore di B.M.I. almeno pari a 18,5. (Sì, ho mollato anche questa nutrizionista, naturalmente.) Certamente il B.M.I. può essere considerato un buon range nella valutazione del peso corporeo, perchè ci sono studi scientifici che dimostrano che le persone che hanno una maggiore aspettativa di vita e una minore incidenza delle malattie, sono effettivamente quelle che hanno un B.M.I. compreso tra 18,5 e 25. Ma questo non è comunque un assoluto, è solo una statistica, e il peso del singolo non risponde alla statistica, bensì risponde al proprio patrimonio genetico. Il set-point di peso corporeo è una cosa assolutamente individualizzata, e sebbene in molti casi cada in quello che il B.M.I. definisce “normopeso”, nulla vita che possa cadere anche sopra o sotto questo range, e che la persona sia comunque in salute, perché è fisiologicamente geneticamente settata su un peso al di fuori del normopeso stimato col B.M.I..
Inoltre, quando si fa una valutazione sul peso di una persona che ha un DCA, credo sia di fatto estremamente difficile determinare quale sia il “peso corporeo ideale” che essa dovrebbe raggiungere. Può infatti sorgere spontaneo il pensiero: il mio “peso corporeo ideale” è quello che avevo prima di ammalarmi di anoressia. Okay… ma questo è solo parzialmente vero. Perché se una ragazza si ammala di anoressia a 10 anni, avrebbe ancora un bel po’ di sviluppo da fare… e – annuncio di pubblico servizio – non è generalmente salutare per una donna pesare quanto pesava quando era una 10enne. Poi, certo, se una si ammala a 25 anni, allora il discorso del tornare al peso precedente alla malattia ha un senso… ma occorre non farci fuorviare da questa considerazione.
Il problema è che l’idea di “peso corporeo ideale” è veicolata da un enorme bagaglio culturale. Fortunatamente, ultimamente mi è capitato di leggere su Internet che ci sono diversi professionisti nel campo dei DCA che cercano di spiegare e di far passare l’idea che si può essere in salute anche se si indossano taglie diverse, che c’è più da puntare sulla terapia degli aspetti mentali dell’anoressia, e non limitarsi a valutare solamente l’aspetto della rialmentazione… e questo mi dà un po’ di speranza, perché vedo che c’è gente che finalmente apre gli occhi.
E dunque, se non usiamo “peso corporeo ideale”, qual è l’alternativa? Peso target? Forse… ma per le adolescenti, in pieno periodo di crescita e sviluppo, i target non sono stazionari. Perciò, penso che dovremo lasciar andare l’idea di “peso corporeo ideale/previsto”, e focalizzarsi invece (oltre che, ovviamente, sugli aspetti mentali della malattia) su qual è il set-point di peso biologico di ciascuna paziente. Fare un discorso assolutamente individualizzato, lasciando perdere le generalizzazioni. Ognuna di noi discende da una certa famiglia, ha la propria genetica, il proprio morfotipo, le proprie peculiarità costituzionali. Ogni persona ha un suo proprio range di peso corporeo che è biologicamente appropriato per lei stessa. Niente a che vedere con i target o con l’idealità, bensì con la genetica, la biologia, e il set-point di ciascuna di noi. Questa è la realtà.
Occorre smetterla di pensare che esista un valore univoco di B.M.I. che definisce lo stato di salute o il “peso corporeo ideale” delle persone. Occorre smetterla di pensare che essere sottopeso sia solo e soltanto sinonimo di avere un B.M.I. < 18,5. Non è così. Ognuna di noi ha il suo set-point fisiologico di peso corporeo, un suo proprio range di “normalità”: si è sottopeso se si scende al disotto di quel proprio ed individuale range. Ma questo range non necessariamente corrisponde a quello del B.M.I.. Per quanto la maggior parte delle persone abbia effettivamente un set-point fisiologico ascrivibile ad un B.M.I. compreso tra 18,5 e 25, ci sono alcune persone che per stare bene hanno bisogno di un peso che corrisponde ad un B.M.I. > 25, e alcune altre persone che sono perfettamente in salute pur con un B.M.I. < 18,5. È la variabilità interindividuale, quella che non può essere assoggettata a nessuna statistica. Per cui, se per esempio c’è una ragazza il cui set-point di peso fisiologico corrisponde ad un B.M.I. = 26, e poi il suo peso cala fino ad arrivare ad un B.M.I. = 23, la statistica dice che è meglio, perché la ragazza è passata da un sovrappeso ad un normopeso… ma, in realtà, rispetto al suo standard fisiologico, la ragazza in questione non è normopeso, bensì sottopeso! E, per lei, quella non rappresenta perciò una situazione di salute. Ragionare per numeri aiuta senz’altro a schematizzare, ma non dimentichiamo che le statistiche non possono trascendere l’individualità. Dobbiamo dunque essere consapevoli del fatto che alcune persone hanno set-point di peso biologicamente appropriati che sono anche al di sopra di B.M.I. = 25, o al di sotto di B.M.I. = 18,5. E va bene così.
In un mondo di circa 7 miliardi d’individui, non esiste alcun assoluto “peso corporeo ideale”. È un qualcosa di assolutamente variabile e soggettivo. Prima accetteremo questo dato di fatto, meglio staremo tutti quanti.
Etichette:
alimentazione,
anoressia,
binge,
bulimia,
dca,
dieta,
DSM,
no pro ana,
nutrizionista,
peso corporeo,
peso ideale,
psichiatra,
ricovero,
set-point
Iscriviti a:
Post (Atom)