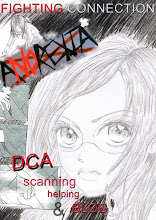Nel suo commento, ButterflyAnna scrive: “sfido chiunque di voi a dire che all'inizio di questa malattia non avete pensato che perdere chili su chili e non mangiare fosse la cosa più giusta del mondo […] era solo voler dimagrire e voler restringere a tutti i costi […]Perché il pensiero era quello e i comportamenti erano quelli di una ragazza che voleva diventare sempre più magra a ogni costo […]Poi a quei 36 chili ci sono arrivata e non mi hanno portato felicità solo a quel punto ho capito di essere malata”.
In rigoroso ordine random, partiamo da valle per arrivare a monte.
Io credo che la fisicità non sia un parametro poi così strettamente attendibile per valutare la “malattia”/“guarigione” da un DCA. Anche perché sono dell’idea che ciò che rende una persona affetta da anoressia non è il peso ma i pensieri, cioè il pattern mentale – essendo l’anoressia malattia mentale per psichiatrica definizione. Per cui, come ho già scritto altrove, ritengo che una persona possa essere malata di anoressia anche se pesa 150 Kg, se la sua forma mentis è quella propria dell’anoressia, perché è il quadro mentale che connota l’anoressia, non la fisicità.
È ovvio, e lo capisce anche un bambino, che ci sono certi livelli di sottopeso che per forza non sono compatibili con la salute. Riprendendo l’esperienza raccontata da ButterflyAnna, è palese che una donna che pesa 36 Kg (a meno che non sia alta un metro e un cavolo) non può essere in salute e deve recuperare, su questo credo non ci sia neanche da discutere.
Per il resto, il termine “sottopeso” (come il termine “sovrappeso”, del resto) è molto generico, e pertanto di pressoché impossibile applicazione su vasta scala, data l’estrema soggettività di ognuna di noi. Quello che andrebbe considerato – e che sarebbe in effetti scientificamente corretto considerare, come dimostrano diversi studi recentemente condotti – è il Set-Point di peso corporeo fisiologico, che è un qualcosa di individualizzato per ciascuna di noi, e non risponde propriamente al canonico concetto di “normopeso secondo il B.M.I.” (sebbene sia vero che molte persone hanno un proprio Set-Point che corrisponde ad un valore di B.M.I. compreso nel range del normopeso). Il Set-Point è una sorta di “termostato del peso corporeo” che viene geneticamente determinato, ed è regolato per essere mantenuto intorno ad un punto fisso da complessi meccanismi di feedback (omeostasi). Questi meccanismi di equilibrio tendono a mantenere il valore di peso preimpostato dal Set-Point relativamente costante.
Il peso ovviamente sballa di molto quando, con un DCA, ci alimentiamo in maniera del tutto anomala e pieghiamo l’organismo alterando il metabolismo e dunque perdendo/prendendo peso. Tuttavia, poiché il Set-Point di peso corporeo fisiologico è appunto geneticamente determinato, nel momento in cui si riprende ad alimentarci regolarmente e correttamente, dopo il tempo necessario al metabolismo per riattivarsi e ricominciare a lavorare a regime, il nostro organismo tenderà a riportare il peso ai valori originari.
E questo giusto per chiarire da un punto di vista prettamente medico i discorsi sul sottopeso/sovrappeso.
Per quanto riguarda il concetto di “guarigione”, purtroppo è vero che molte persone che non hanno vissuto un DCA sulla propria pelle si fermano all’esteriorità, che è l’unica cosa che riescono a vedere e quindi a concepire, e pensano che il peso corporeo sia l’unico parametro che possa decretare lo stato di “guarigione” o meno di una persona. Ovviamente chiunque abbia avuto/abbia un DCA credo sappia bene che non è semplicemente così che stanno le cose.
Io penso che si dovrebbe focalizzare un po’ meno l’attenzione sul peso, e concentrarla maggiormente sulla qualità della vita. Quando si parla di “qualità della vita”, infatti, si fa contemporaneamente riferimento sia al campo fisico che a quello psicologico: è indubbio che non si possa avere una buona qualità della vita con un corpo fisicamente non in salute (vuoi per il sottopeso eccessivo in chi è affetta da anoressia, vuoi per i danni prodotti dalle condotte di compensazione in chi è affetta da bulimia, vuoi per le abbuffate in chi soffre di binge, vuoi per l’alimentazione altalenante in chi ha un DCAnas, etc…), e allo stesso tempo è indubbio che non si possa avere una buona qualità della vita con una mentalità pervasa dal DCA... perché tanto più esso è presente nella nostra testa, tanto più si perde in vita sociale, lavoro, studio, sport, e tutte quelle cose che rendono la nostra vita appunto una vita di qualità.
Ergo, secondo me è la qualità della vita che va a valutare quanto una persona sia “guarita” o meno da un DCA, compendiando sia gli aspetti fisici che quelli mentali… ammesso e non concesso che per malattie come i DCA si possa parlare di “guarigione”. Io infatti preferisco il termine “remissione” e sottolineo che, personalmente, non sono “guarita” dall’anoressia nel senso canonico del termine, perché mi capita tuttora di avere talvolta dei pensieri, che però riconosco come malati, e dunque non agisco. So che ci sono, ma li lascio lì, confinati in quell’angolino della mia testa, e non mi condizionano più nè comportamentalmente né mentalmente. È proprio per questo che ormai fortunatamente da diversi anni sto vivendo una remissione della malattia.
Tornando invece a monte, e dunque facendo riferimento alla prima parte del commento di ButterflyAnna, premetto che: quello che sto per scrivere fa parte della mia esperienza personale, ergo non ha alcun valore a carattere generale. Ciò significa che probabilmente alcune di voi si rispecchieranno comunque in ciò che scrivo, ed altre no. In ogni caso, nessuna pretesa di verità assoluta: semplicemente quello che ho vissuto io, e dunque la MIA personale verità, più o meno estendibile agli altri.
Nelle parole di ButterflyAnna, io NON mi ritrovo PER NIENTE
Se vogliamo considerare il B.M.I. come riferimento, allora è tutta la vita che io sono “sottopeso”. Giusto per dire, se vogliamo considerare il B.M.I. come riferimento, allora tutti i membri della mia famiglia sono “sottopeso” da tutta la vita (eppure nessuno di loro ha un DCA). Sono sempre stata magra (e bassa) credo semplicemente perché, geneticamente, provengo da una famiglia in cui siamo tutti magri (e bassi): se di “sottopeso” vogliamo parlare, è un “sottopeso” del tutto fisiologico, che ci caratterizza tutti quanti. Poi, personalmente, con l’anoressia, ho ovviamente trasceso ogni limite di peso e sono arrivata ad una magrezza assolutamente patologica e del tutto incompatibile con la salute. Tuttavia attualmente, grazie all’aiuto della dietista che tuttora mi segue, ho recuperato il mio Set-Point di peso fisiologico, sto pertanto seguendo un “equilibrio alimentare” mirato proprio al mantenimento di questo peso e naturalmente all’evitamento della riadozione di comportamenti alimentari restrittivi e, salvo i danni permanenti che l’anoressia ha prodotto al mio corpo e che purtroppo mi dovrò portare dietro vita natural durante (mi riferisco a osteopenia e infertilità), sono perfettamente in salute e posso senza alcun problema fare sport, lavorare come istruttrice ed arbitro di karate, lavorare come medico, e se mi avanza un po’ di tempo nelle mie incasinatissime giornate anche prendermi un attimo di pausa per dedicarmi alle cose che mi piacciono come per esempio leggere e disegnare.
Essere perfettamente in salute da un punto di vista prettamente fisico non significa appunto, come dicevo, essere del tutto “guarita” dall’anoressia, perché se così fosse immagino che certi pensieri non mi passerebbero più neanche per l’anticamera del cervello. Ma significa che attualmente ho un corpo in salute e del tutto funzionale che mi permette di vivere a 360°, e che mi ha consentito di tornare ad avere un’ottima qualità della vita.
Io non ho mai avuto dunque il desiderio di essere magra poiché, banalmente, sono sempre stata magra.
Per quanto attiene la mia personale esperienza, il bisogno di controllo è stato il punto focale di tutto il disturbo alimentare. Io volevo avere il controllo assoluto. Su tutto. Su ogni singolo aspetto della mia vita. La cosa è partita da ambiti diversi dall’alimentazione e poi, in un formidabile colpo di coda, anche il versante alimentare è stato tirato dentro questo mio bisogno di programmare – e dunque controllare – ogni singolo secondo delle mie giornate.
Volevo “semplicemente” avere sotto controllo ogni singolo respiro della mia vita, e questo controllo che già mettevo in atto su altre cose, ad un certo punto ha iniziato a passare anche attraverso il canale alimentare. L’obiettivo della mia restrizione, in effetti era proprio questo: elaborare una forma di controllo su quello che mangiavo. Il dimagrimento è stata l’ovvia conseguenza, ma non mi ha mai fatto piacere, anzi, mi metteva a disagio, non avrei voluto (anche perché comprometteva le mie prestazioni sportive, e al tempo facevo agonismo ed ero a buon livello), ma avevo bisogno del controllo, e se “il prezzo da pagare” era quello di perdere chili, allora andava bene tutto, allora accettavo il compromesso, pur di non abbandonare la sensazione di sicurezza e di forza che quel (l’illusorio) controllo mi faceva provare.
Non ho mai avuto, dunque, l’obiettivo di restringere l’alimentazione per dimagrire (difatti non mi sono mai pesata, neanche nella fase più acuta dell’anoressia, proprio perché del peso in sé non me ne poteva fregare di meno, né ho mai contato le calorie o cose del genere), il mio unico pensiero era incentrato sul desiderio di avere il controllo su tutto. Ogni altra cosa era mera conseguenza.
Mai voluto diventare più magra… ma sempre voluto esercitare un controllo sempre più totale.
Salvo poi rendermi conto, ovviamente, che quell’anoressia che credevo di controllare, era proprio ciò che mi controllava in misura spietata.