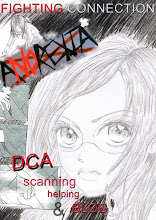Visualizzazione post con etichetta studio scientifico. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta studio scientifico. Mostra tutti i post
venerdì 28 marzo 2014
Quest'immagine potrebbe essere dannosa per la tua salute
Come ho già scritto più e più volte, NON credo che i mass-media siano responsabili dell’anoressia. NON credo che vedere le immagini di modelle particolarmente magre possa causare un DCA. È pur vero che, se queste cose non sono determinanti nella comparsa dell’anoressia, di certo non sono comunque utili né positive per chi ha un disturbo alimentare (ma anche per che non ce l’ha, se è per questo). E certe immagini non le possiamo evitare, per quanto si tenti: riviste, TV, cartelloni pubblicitari ci stanno sotto gli occhi tutti i giorni. E non è infrequente – soprattutto nelle riviste più modaiole e molto lette per lo più da un pubblico giovane di sesso femminile – trovare fotografie di modelle opportunamente ritoccate con qualche programma di elaborazione digitale.
Personalmente, non ho nulla in contrario ad un moderato uso di Photoshop per cancellare qualche imperfezione cutanea o per far risaltare determinati colori o cose del genere. La fotografia è una forma di arte, dopotutto.
Ma quando questi software vengono utilizzati per ritoccare pesantemente l’immagine delle modelle, quando queste diventano più digitali che umane, quando non c’è alcun modo che certi capi d’abbigliamento presenti in un’immagine possano riflettere ciò che effettivamente succede quando un reale essere umano li indossa, ecco, questo secondo me è scorretto (per non usare una parola più offensiva, che inizia sempre per “S”…). E’ nient’altro che pubblicità ingannevole. E il vedere delle immagini del genere incasina non poco le nostre sinapsi neuronali.
L’immagine di una modella esageratamente magra ci dice, indirettamente, che è possibile arrivare in tranquillità ad avere un peso del genere. Perché il nostro cervello non è programmato per pensare al fotoritocco, ma solo per esaminare le immagini che gli vengono poste di fronte: se vede una ragazza sorridente ad un peso improbabile, il pensiero di fondo sarà quello che è possibile essere felici quando si è estremamente sottopeso. È un’enorme cavolata, ovviamente, ma è così che rudimentalmente funziona la nostra mente. Pochi esseri umani hanno un sottopeso fisiologico, e neanche coloro che sono fisiologicamente magri si avvicinano alla magrezza di certe modelle che si vedono nei giornali o nei cartelloni pubblicitari.
Scrivono la ricercatrice Marika Tiggemann e i suoi colleghi in un articolo sulla rivista “Body Image”:
“[…] Anche sfogliando distrattamente una qualsiasi rivista modaiola, sarà possibile notare una vasta pletora di ragazze giovani, alte, con gambe lunghissime, occhi grandi da cerbiatto, pelle liscia come una pesca, tratti somatici tipicamente caucasici. Queste stesse immagini mostrano modelle estremamente magre. Non sono semplicemente donne naturalmente magre, ma le moderne tecniche di modificazione digitale sono ad oggi utilizzate di routine per allungare le gambe, togliere peso e centimetri dalla vita, dai fianchi, dalle cosce, ed eliminare ogni qualsiasi difetto. (Bennet, 2008). Così presentati, gli standard fisici proposti dai mass-media diventano ancor più irrealistici ed irraggiungibili per la donna media. […]”
(mia traduzione)
È luogo comune diffuso che questi modelli di eccessiva magrezza proposti dai mass-media giochino una parte importante nella genesi dei DCA. Come sapete, io la penso diversamente. Io non credo che cose del genere abbiamo il potere di far nascere un disturbo alimentare in un soggetto che non ha alcun altro fattore predisponente per questo tipo di malattia. Non credo che possano essere una significativa causa nemmeno in chi ha fattori predisponenti. Però credo che senz’altro il vedere immagini di questo tipo non faccia bene a nessuno, non sia in alcun modo d’aiuto, soprattutto per chi sta combattendo contro il proprio DCA.
Alcuni Paesi hanno proposto di varare una legge che imponga a chiunque pubblichi foto di modelle, di segnalare con apposita etichetta quelle che sono state alterate con programmi di fotoritocco. L’idea di base è che, se si è consapevoli che quelle immagini sono fake, se ci viene sbattuto sotto gli occhi il fatto che sono fake, allora verrà ascritta loro meno importanza e credibilità. A naso, ho subito concordato con quest’idea. Ma poi ho scoperto un recentissimo studio scientifico elaborato da Tiggemann e colleghi, che viceversa mostra come etichette di questo genere non sono utili come potrebbe sembrare a istinto. Anzi, non sono utili affatto.
Cos'hanno scoperto i ricercatori:
I ricercatori hanno reclutato per il loro studio 120 studentesse universitarie di età compresa tra i 18 e i 35 anni, facendo vedere loro 15 pagine di una rivista piene di foto di modelle eccessivamente magre. Alcune di queste immagini erano prive di ogni qualsiasi etichetta, alcune erano accompagnate da un’etichetta generica (“Attenzione: Quest’immagine è frutto di fotoritocco”), alcune erano accompagnate da un’etichetta specifica (“Attenzione: Quest’immagine è frutto di fotoritocco utilizzato per rendere la pelle più liscia, i muscoli più tonici, le braccia, le gambe ed i fianchi più magri”). Laddove presenti, le etichette erano piazzate alla destra o alla sinistra dell’immagine della modella, in maniera tale che fossero ben visibili (Font: Calibri, Dimensione carattere: 11). I ricercatori hanno anche organizzato un gruppo di controllo, costituito da donne con le medesime caratteristiche, cui venivano fatte vedere fotografie di accessori, o di automobili, o comunque di oggetti inanimati. Dopo aver visualizzato le immagini, a tutte le donne era richiesto di rispondere ad una serie di domande relative al loro umore e all’insoddisfazione per la propria fisicità, nonché relative alla loro considerazione in generale relativamente al proprio corpo.
Le donne che avevano guardato le foto delle modelle rivelavano un’insoddisfazione per il proprio corpo maggiore rispetto a quelle che avevano visto le foto di oggetti inanimati. Allo stesso tempo, il livello d’insoddisfazione era pressoché identico sia in chi aveva guardato foto non contrassegnate, sia in chi aveva guardato foto accompagnate da etichette. In altre parole, quelle donne provavano insoddisfazione per la propria fisicità anche se erano pienamente consapevoli che le immagini guardate erano fake. Il pensiero sottostante di queste donne immagino sia stato: “Se persino le modelle hanno bisogno di un pesante fotoritocco per apparire in questo modo, immagina di quanto “aiuto” ho bisogno io per sembrare anche solo lontanamente simile a loro”.
Una variabile che appare significativa è un fattore chiamato “comparazione sociale”. Consiste sostanzialmente nella frequenza con cui una persona paragona il proprio corpo a tutte coloro che la circondano (e si sentono sempre inferiori alle altre, e sempre colpevoli per questo). Le donne che hanno questo tipo di problema sono quelle più vulnerabili alla visione di certi tipi d’immagini, nonché – secondo lo studio – quelle la cui insoddisfazione per il proprio corpo era più elevata anche dopo aver visto le immagini contrassegnate da etichette.
I ricercatori hanno ripetuto una seconda volta un esperimento del tutto simile, che ha sostanzialmente confermato i risultati del precedente.
Gli autori dello studio hanno quindi concluso:
“Dai risultati di questo studio si evince che, anziché interrompere o prevenire la comparazione sociale come desiderato, il vedere immagini contenenti etichette d’avvertimento implementa la comparazione sociale stessa. Forse perché dette etichette fanno focalizzare ancor di più l’attenzione sul corpo della modella, anziché guardare l’immagine nel suo insieme. Questo è confermato dal fatto che, soprattutto in quelle donne che hanno problemi di spiccata comparazione sociale, la presenza delle etichette accanto alle immagini accresce la loro insoddisfazione nei confronti della propria fisicità. […]”
(mia traduazione)
Io immagino che questo dipenda dal fatto che la maggior parte di noi, in fondo, sa perfettamente che le foto delle modelle che si vedono sono fotoritoccate. A livello cognitivo, razionale, sappiamo bene che sono fake. Ma è nel gap che intercorre tra visualizzazione di un’immagine e sua interpretazione razionale che si cela l’emotività. E l’emotività non può essere cancellata da nessuna etichetta d’avvertimento. Inoltre, queste etichette fanno sì che la concentrazione si focalizzi molto di più sul corpo della modella, cercando di vedere quali parti non sono “reali”, e scrutando ogni singolo dettaglio per individuare possibili segni d’alterazione e rielaborazione digitale.
In poche parole, io credo che ci sarebbe bisogno di una maggiore variabilità nelle immagini che ci vengono propinate dai mass-media: sia in termini di taglia, di dimensioni e forme del corpo, sia in termini di etnia, e molti altri fattori di questo tipo. E questo come considerazione generale, rivolta a qualsiasi donna, non necessariamente a chi ha un DCA, perché credo che i disturbi alimentari affondino le loro radici in tutt’altre problematiche ben più profonde e complesse della mera fisicità. Sarebbe bello poter sfogliare una rivista modaiola, ed avere per lo meno l’idea di come un paio di jeans possano vestire su di noi, non su un’immagine ritoccata per essere quanto più vicina possibile ad un appendiabiti…
Personalmente, non ho nulla in contrario ad un moderato uso di Photoshop per cancellare qualche imperfezione cutanea o per far risaltare determinati colori o cose del genere. La fotografia è una forma di arte, dopotutto.
Ma quando questi software vengono utilizzati per ritoccare pesantemente l’immagine delle modelle, quando queste diventano più digitali che umane, quando non c’è alcun modo che certi capi d’abbigliamento presenti in un’immagine possano riflettere ciò che effettivamente succede quando un reale essere umano li indossa, ecco, questo secondo me è scorretto (per non usare una parola più offensiva, che inizia sempre per “S”…). E’ nient’altro che pubblicità ingannevole. E il vedere delle immagini del genere incasina non poco le nostre sinapsi neuronali.
L’immagine di una modella esageratamente magra ci dice, indirettamente, che è possibile arrivare in tranquillità ad avere un peso del genere. Perché il nostro cervello non è programmato per pensare al fotoritocco, ma solo per esaminare le immagini che gli vengono poste di fronte: se vede una ragazza sorridente ad un peso improbabile, il pensiero di fondo sarà quello che è possibile essere felici quando si è estremamente sottopeso. È un’enorme cavolata, ovviamente, ma è così che rudimentalmente funziona la nostra mente. Pochi esseri umani hanno un sottopeso fisiologico, e neanche coloro che sono fisiologicamente magri si avvicinano alla magrezza di certe modelle che si vedono nei giornali o nei cartelloni pubblicitari.
Scrivono la ricercatrice Marika Tiggemann e i suoi colleghi in un articolo sulla rivista “Body Image”:
“[…] Anche sfogliando distrattamente una qualsiasi rivista modaiola, sarà possibile notare una vasta pletora di ragazze giovani, alte, con gambe lunghissime, occhi grandi da cerbiatto, pelle liscia come una pesca, tratti somatici tipicamente caucasici. Queste stesse immagini mostrano modelle estremamente magre. Non sono semplicemente donne naturalmente magre, ma le moderne tecniche di modificazione digitale sono ad oggi utilizzate di routine per allungare le gambe, togliere peso e centimetri dalla vita, dai fianchi, dalle cosce, ed eliminare ogni qualsiasi difetto. (Bennet, 2008). Così presentati, gli standard fisici proposti dai mass-media diventano ancor più irrealistici ed irraggiungibili per la donna media. […]”
(mia traduzione)
È luogo comune diffuso che questi modelli di eccessiva magrezza proposti dai mass-media giochino una parte importante nella genesi dei DCA. Come sapete, io la penso diversamente. Io non credo che cose del genere abbiamo il potere di far nascere un disturbo alimentare in un soggetto che non ha alcun altro fattore predisponente per questo tipo di malattia. Non credo che possano essere una significativa causa nemmeno in chi ha fattori predisponenti. Però credo che senz’altro il vedere immagini di questo tipo non faccia bene a nessuno, non sia in alcun modo d’aiuto, soprattutto per chi sta combattendo contro il proprio DCA.
Alcuni Paesi hanno proposto di varare una legge che imponga a chiunque pubblichi foto di modelle, di segnalare con apposita etichetta quelle che sono state alterate con programmi di fotoritocco. L’idea di base è che, se si è consapevoli che quelle immagini sono fake, se ci viene sbattuto sotto gli occhi il fatto che sono fake, allora verrà ascritta loro meno importanza e credibilità. A naso, ho subito concordato con quest’idea. Ma poi ho scoperto un recentissimo studio scientifico elaborato da Tiggemann e colleghi, che viceversa mostra come etichette di questo genere non sono utili come potrebbe sembrare a istinto. Anzi, non sono utili affatto.
Cos'hanno scoperto i ricercatori:
I ricercatori hanno reclutato per il loro studio 120 studentesse universitarie di età compresa tra i 18 e i 35 anni, facendo vedere loro 15 pagine di una rivista piene di foto di modelle eccessivamente magre. Alcune di queste immagini erano prive di ogni qualsiasi etichetta, alcune erano accompagnate da un’etichetta generica (“Attenzione: Quest’immagine è frutto di fotoritocco”), alcune erano accompagnate da un’etichetta specifica (“Attenzione: Quest’immagine è frutto di fotoritocco utilizzato per rendere la pelle più liscia, i muscoli più tonici, le braccia, le gambe ed i fianchi più magri”). Laddove presenti, le etichette erano piazzate alla destra o alla sinistra dell’immagine della modella, in maniera tale che fossero ben visibili (Font: Calibri, Dimensione carattere: 11). I ricercatori hanno anche organizzato un gruppo di controllo, costituito da donne con le medesime caratteristiche, cui venivano fatte vedere fotografie di accessori, o di automobili, o comunque di oggetti inanimati. Dopo aver visualizzato le immagini, a tutte le donne era richiesto di rispondere ad una serie di domande relative al loro umore e all’insoddisfazione per la propria fisicità, nonché relative alla loro considerazione in generale relativamente al proprio corpo.
Le donne che avevano guardato le foto delle modelle rivelavano un’insoddisfazione per il proprio corpo maggiore rispetto a quelle che avevano visto le foto di oggetti inanimati. Allo stesso tempo, il livello d’insoddisfazione era pressoché identico sia in chi aveva guardato foto non contrassegnate, sia in chi aveva guardato foto accompagnate da etichette. In altre parole, quelle donne provavano insoddisfazione per la propria fisicità anche se erano pienamente consapevoli che le immagini guardate erano fake. Il pensiero sottostante di queste donne immagino sia stato: “Se persino le modelle hanno bisogno di un pesante fotoritocco per apparire in questo modo, immagina di quanto “aiuto” ho bisogno io per sembrare anche solo lontanamente simile a loro”.
Una variabile che appare significativa è un fattore chiamato “comparazione sociale”. Consiste sostanzialmente nella frequenza con cui una persona paragona il proprio corpo a tutte coloro che la circondano (e si sentono sempre inferiori alle altre, e sempre colpevoli per questo). Le donne che hanno questo tipo di problema sono quelle più vulnerabili alla visione di certi tipi d’immagini, nonché – secondo lo studio – quelle la cui insoddisfazione per il proprio corpo era più elevata anche dopo aver visto le immagini contrassegnate da etichette.
I ricercatori hanno ripetuto una seconda volta un esperimento del tutto simile, che ha sostanzialmente confermato i risultati del precedente.
Gli autori dello studio hanno quindi concluso:
“Dai risultati di questo studio si evince che, anziché interrompere o prevenire la comparazione sociale come desiderato, il vedere immagini contenenti etichette d’avvertimento implementa la comparazione sociale stessa. Forse perché dette etichette fanno focalizzare ancor di più l’attenzione sul corpo della modella, anziché guardare l’immagine nel suo insieme. Questo è confermato dal fatto che, soprattutto in quelle donne che hanno problemi di spiccata comparazione sociale, la presenza delle etichette accanto alle immagini accresce la loro insoddisfazione nei confronti della propria fisicità. […]”
(mia traduazione)
Io immagino che questo dipenda dal fatto che la maggior parte di noi, in fondo, sa perfettamente che le foto delle modelle che si vedono sono fotoritoccate. A livello cognitivo, razionale, sappiamo bene che sono fake. Ma è nel gap che intercorre tra visualizzazione di un’immagine e sua interpretazione razionale che si cela l’emotività. E l’emotività non può essere cancellata da nessuna etichetta d’avvertimento. Inoltre, queste etichette fanno sì che la concentrazione si focalizzi molto di più sul corpo della modella, cercando di vedere quali parti non sono “reali”, e scrutando ogni singolo dettaglio per individuare possibili segni d’alterazione e rielaborazione digitale.
In poche parole, io credo che ci sarebbe bisogno di una maggiore variabilità nelle immagini che ci vengono propinate dai mass-media: sia in termini di taglia, di dimensioni e forme del corpo, sia in termini di etnia, e molti altri fattori di questo tipo. E questo come considerazione generale, rivolta a qualsiasi donna, non necessariamente a chi ha un DCA, perché credo che i disturbi alimentari affondino le loro radici in tutt’altre problematiche ben più profonde e complesse della mera fisicità. Sarebbe bello poter sfogliare una rivista modaiola, ed avere per lo meno l’idea di come un paio di jeans possano vestire su di noi, non su un’immagine ritoccata per essere quanto più vicina possibile ad un appendiabiti…
Etichette:
anoressia,
binge,
bulimia,
dca,
etichette,
fotomodelle,
fotoritocco,
immagine corporea,
insoddisfazione,
magrezza,
mass-media,
modelle,
no pro ana,
peso,
Photoshop,
ricovero,
studio scientifico
venerdì 3 gennaio 2014
Diete e anoressia
Uno dei tanto classici quanto falsi luoghi comuni sull’anoressia, è che essa rappresenta il risultato di una dieta andata a finire male. Okay, dato che la maggior parte della gente pensa che l’anoressia sia la conseguenza di una dieta degenerata, vediamo un po’ di sfatare questo mito. E non semplicemente con il mio parere che, opinabile per definizione, ha una validità estremamente limitata, ma con l’aiuto di uno studio scientifico condotto da alcuni ricercatori finlandesi nel 2010.
Tanto per cominciare, immaginatevi due ipotetiche adolescenti: Adolescente A e Adolescente B. Entrambe le adolescenti “fanno una dieta”. Il che potrebbe significare che vogliono perdere qualche chilo, oppure che vogliono eliminare i fuoripasto e mangiare in maniera salutare, oppure che vogliono fare più attività fisica. A prescindere dal perché, le due ragazze iniziano a ridurre l’alimentazione in quantità e qualità. Adolescente A si comporta come la stragrande maggioranza delle persone che decidono di “mettersi a dieta”: un po’ riesce a seguirla, un po’ non ci riesce. Perde qualche chilo, poi lo riprende. In certi momenti fa più sport, in altri ne fa di meno. Dopo un po’ si annoia, e lascia perdere. Insomma, alla fin fine sta comunque bene. Per Adolescente B, invece, le cose vanno diversamente: si ammala di anoressia.
Le motivazioni tali per cui una persona sviluppa un DCA sono estremamente numerose nonché variabili da individuo ad individuo, poiché ogni persona ha un differente patrimonio genetico, un differente carattere, un differente background, delle differenti esperienze di vita, che si embricano in maniera estremamente complessa tra di loro, per dare vita al DCA stesso. Per cui, la frase “L’anoressia inizia con una dieta andata a finire male” mi sembra estremamente riduttiva. Sicuramente all’esordio dell’anoressia c’è una restrizione alimentare, per cui potrebbe semmai essere più corretto il dire: “L’anoressia inizia con un bilancio energetico negativo”… ma non è questo il punto. Perché è molto più vero il contrario: la stragrande maggioranza delle diete non portano all’anoressia. Dunque, cos’è che rende una piccola percentuale di persone vulnerabili allo sviluppo di un conclamato DCA dopo un periodo di bilancio energetico negativo?
Alcuni ricercatori finlandesi, perciò, hanno deciso di provare a vedere se esistesse un modo per predire quali, tra le millemila ragazzine che “fanno la dieta”, avessero un più alto rischio di sviluppare un disturbo alimentare conclamato. Il loro studio ha dimostrato che esiste. La risposta sembra essere legata alla comprensione di quelle che sono le vere motivazioni che spingono una ragazza a restringere l’alimentazione. Se l’intraprendere un regime alimentare restrittivo è motivato da manie di controllo, ansia, ossessività, senso di colpa, difficoltà relazionali, pregressi eventi vissuti come traumatici, scarsa autostima, rabbia, etc, sarà molto facile che la persona sviluppi l’anoressia, cosa che invece non succede praticamente mai alle persone che si mettono a dieta prettamente per motivi estetici.
Questi scienziati finlandesi sono dunque partiti proprio da questa domanda: quali fattori rendono alcune adolescenti più propense a sviluppare un DCA rispetto ad altre, che pure “fanno la dieta”? Nel formulare il loro studio hanno prestato attenzione non solo alle differenze nel comportamento alimentare ma soprattutto (la parte più importante del loro studio, a mio avviso) a numerose variabili psicologiche – il che dimostra che l’anoressia non è banalmente una “dieta degenerata”, ma ci stano ben altre problematiche dietro. Insomma, per rispondere alla domanda questi scienziati hanno inizialmente reclutato 595 ragazze finlandesi di 15 anni. Tutte queste ragazze hanno risposto a dei questionari relativi alla loro passata/presente salute fisica e mentale, ai loro comportamenti, alle loro esperienze di vita, e ad alcune brevi domande relative a diete e DCA. (Isomaa et al., 2010).
128 di queste ragazze avevano comportamenti alimentari restrittivi e rispondevano a uno o più dei criteri diagnostici del DSM-IV per i DCA, per cui sono state richiamate per interviste face-to-face più dettagliate. Solo 113 delle 128 ragazze sono ritornate per sottoporsi al colloquio orale, e di queste 81 sono state considerate “a rischio sviluppo anoressia”. Soltanto 65 di queste, però, si sono presentate ai successivi follow-up. I ricercatori però non hanno condotto ulteriori indagini sulle ragazze che seguivano una dieta ma non rispondevano a nessun criterio del DSM-IV per i DCA, e non le hanno neanche sottoposte a follow-up: questo secondo me è il grosso punto debole di questo studio (anche perché le persone indagate sono rimaste solo quelle che fin dall’inizio presentavano un comportamento borderline verso il DCA, il che ha probabilmente influenzato negativamente la significatività dei loro risultati).
Ad ogni modo, con le 81 interviste orali ottenute, i ricercatori hanno suddiviso le quindicenni in 4 gruppi mutualmente esclusivi (le cui descrizioni le traduco direttamente dallo studio in questione):
A dieta per vanità (in originale: “Vanity Dieters” – mi scuso per le pessime traduzioni di questi termini, ma non esiste un diretto equivalente in italiano) (28 ragazze). Le ragazze a dieta per vanità hanno iniziato la loro dieta per ottenere un corpo più snello, più sensuale e più appetibile, potremmo dire più in linea con gli standard della società odierna. Si mettono dunque a dieta con un obiettivo ben preciso, e generalmente la loro dieta prevede l’eliminazione di cibi ad alto contenuto calorico, dei dolci, associato ad un modesto incremento dell’attività fisica.
A dieta per sovrappeso (in originale: “Overweight Dieters”) (12 ragazze). Le ragazze a dieta per sovrappeso hanno iniziato la loro dieta per cercare di evitare la comparsa di quelle patologie che tipicamente si associano al sovrappeso e all’obesità (come per esempio il Diabete Mellito di tipo II, l’ipertensione arteriosa, la sindrome metabolica, etc…). La loro dieta è moderata, e anche l’esercizio fisico è contenuto e regolare. Questo gruppo include solo e soltanto ragazze che quando si sono messe a dieta erano oggettivamente sovrappeso (B.M.I.>25).
A dieta per sconquasso emotivo (in originale: “Depressed Dieters”) (33 ragazze). Le ragazze a dieta per sconquasso emotivo hanno iniziato la loro dieta in un momento particolarmente difficile della loro vita, che le aveva emotivamente molto scosse, con l’idea che le loro problematiche avrebbero potuto migliorare perdendo del peso. La tipologia di dieta è variabile tra queste ragazze, ma nella maggior parte dei casi è caratterizzata dal saltare pasti, abbuffarsi e poi vomitare, assumere lassativi, o fare tantissima attività fisica per regolare l’apporto energetico.
A dieta per bisogno di controllo (in originale: “Controllers Dieters”) (8 ragazze). Le ragazze a dieta per bisogno di controllo forniscono proprio questa spiegazione quando vengono chieste le motivazioni per cui la dieta è stata intrapresa: perché avevano bisogno di controllare tutto, anche l’alimentazione. Nella stragrande maggioranza dei casi sono ragazze originariamente normopeso o addirittura sottopeso. La loro dieta consiste nel ridurre progressivamente quantità e variabilità degli alimenti ingeriti.
[La descrizione dell’ultima categoria mi colpisce molto perchè personalmente me la ritrovo in pieno, dal momento che la mia restrizione alimentare è stata sempre strettamente legata alla mia necessità di sentire che tenevo tutto sotto controllo, alimentazione compresa.]
Fatta questa prima suddivisione in 4 gruppi, i ricercatori hanno considerato i primi 2 separatamente dagli altri 2: ai primi 2 gruppi è stato ascritto un basso rischio di sviluppare un DCA, viceversa gli ultimi 2 gruppi sono stati definiti come ad alto rischio di DCA.
Questa suddivisione è stata confermata ad un follow-up eseguito dopo 3 anni, ad Agosto 2013. Nelle persone appartenenti ai primi 2 gruppi, quelli considerato cioè a basso rischio, solo 3 persone avevano sviluppato un DCA subclinico, e nessuna un DCA conclamato. Viceversa, negli altri 2 gruppi, ovvero quelli considerati ad alto rischio, ben 10 avevano sviluppato un DCA subclinico, e addirittura 19 avevano sviluppato un DCA conclamato. Le differenze sono evidentemente statisticamente significative: le ragazze dei 2 gruppi ad alto rischio avevano una probabilità circa 15 volte maggiore di sviluppare un DCA rispetto alle altre. Notevole, come risultato.
Gli autori dello studio concludono:
“Quel che abbiamo scoperto ha palesi implicazioni cliniche: anche il solo chiedere da parte di genitori, insegnanti, allenatori, chiunque stia quotidianamente vicino alle adolescenti, il perché si sono messe a dieta, può dare un’idea della probabilità che quella ragazza possa sviluppare un DCA. Le ragazze che si mettono a dieta perché hanno delle difficoltà nella loro vita quotidiana o delle difficoltà emotive, o che sembrano eccessivamente attratte da un bisogno di controllo, devono essere strettamente monitorate. Lo studio suggerisce inoltre che le diete seguite dalle adolescenti sono sostanzialmente innocue, se non motivate dalle caratteristiche presenti negli ultimi 2 sottogruppi.”
(mia traduzione)
Anche se personalmente non penso che le ragazze originariamente effettivamente sovrappeso che si mettono a dieta debbano essere automaticamente considerate come soggetti a basso rischio di sviluppo di un DCA (poiché io credo che se la persona ha dei vissuti emotivi pesanti o delle manie di controllo, è comunque ad alto rischio, quale che sia il suo peso di partenza), penso che comunque i risultati di questo studio siano importanti ed interessanti, perché mostrano che, appunto, l’anoressia non è la mera conseguenza di una dieta finita male, ma è piuttosto successiva a problematiche psicologiche d’altro tipo. Inoltre questo studio permette, sebbene ovviamente in maniera approssimativa, di valutare sulla base delle motivazioni alla dieta, se la ragazza è effettivamente a rischio di sviluppare un DCA, o se la sua dieta è sostanzialmente innocua.
Tanto per cominciare, immaginatevi due ipotetiche adolescenti: Adolescente A e Adolescente B. Entrambe le adolescenti “fanno una dieta”. Il che potrebbe significare che vogliono perdere qualche chilo, oppure che vogliono eliminare i fuoripasto e mangiare in maniera salutare, oppure che vogliono fare più attività fisica. A prescindere dal perché, le due ragazze iniziano a ridurre l’alimentazione in quantità e qualità. Adolescente A si comporta come la stragrande maggioranza delle persone che decidono di “mettersi a dieta”: un po’ riesce a seguirla, un po’ non ci riesce. Perde qualche chilo, poi lo riprende. In certi momenti fa più sport, in altri ne fa di meno. Dopo un po’ si annoia, e lascia perdere. Insomma, alla fin fine sta comunque bene. Per Adolescente B, invece, le cose vanno diversamente: si ammala di anoressia.
Le motivazioni tali per cui una persona sviluppa un DCA sono estremamente numerose nonché variabili da individuo ad individuo, poiché ogni persona ha un differente patrimonio genetico, un differente carattere, un differente background, delle differenti esperienze di vita, che si embricano in maniera estremamente complessa tra di loro, per dare vita al DCA stesso. Per cui, la frase “L’anoressia inizia con una dieta andata a finire male” mi sembra estremamente riduttiva. Sicuramente all’esordio dell’anoressia c’è una restrizione alimentare, per cui potrebbe semmai essere più corretto il dire: “L’anoressia inizia con un bilancio energetico negativo”… ma non è questo il punto. Perché è molto più vero il contrario: la stragrande maggioranza delle diete non portano all’anoressia. Dunque, cos’è che rende una piccola percentuale di persone vulnerabili allo sviluppo di un conclamato DCA dopo un periodo di bilancio energetico negativo?
Alcuni ricercatori finlandesi, perciò, hanno deciso di provare a vedere se esistesse un modo per predire quali, tra le millemila ragazzine che “fanno la dieta”, avessero un più alto rischio di sviluppare un disturbo alimentare conclamato. Il loro studio ha dimostrato che esiste. La risposta sembra essere legata alla comprensione di quelle che sono le vere motivazioni che spingono una ragazza a restringere l’alimentazione. Se l’intraprendere un regime alimentare restrittivo è motivato da manie di controllo, ansia, ossessività, senso di colpa, difficoltà relazionali, pregressi eventi vissuti come traumatici, scarsa autostima, rabbia, etc, sarà molto facile che la persona sviluppi l’anoressia, cosa che invece non succede praticamente mai alle persone che si mettono a dieta prettamente per motivi estetici.
Questi scienziati finlandesi sono dunque partiti proprio da questa domanda: quali fattori rendono alcune adolescenti più propense a sviluppare un DCA rispetto ad altre, che pure “fanno la dieta”? Nel formulare il loro studio hanno prestato attenzione non solo alle differenze nel comportamento alimentare ma soprattutto (la parte più importante del loro studio, a mio avviso) a numerose variabili psicologiche – il che dimostra che l’anoressia non è banalmente una “dieta degenerata”, ma ci stano ben altre problematiche dietro. Insomma, per rispondere alla domanda questi scienziati hanno inizialmente reclutato 595 ragazze finlandesi di 15 anni. Tutte queste ragazze hanno risposto a dei questionari relativi alla loro passata/presente salute fisica e mentale, ai loro comportamenti, alle loro esperienze di vita, e ad alcune brevi domande relative a diete e DCA. (Isomaa et al., 2010).
128 di queste ragazze avevano comportamenti alimentari restrittivi e rispondevano a uno o più dei criteri diagnostici del DSM-IV per i DCA, per cui sono state richiamate per interviste face-to-face più dettagliate. Solo 113 delle 128 ragazze sono ritornate per sottoporsi al colloquio orale, e di queste 81 sono state considerate “a rischio sviluppo anoressia”. Soltanto 65 di queste, però, si sono presentate ai successivi follow-up. I ricercatori però non hanno condotto ulteriori indagini sulle ragazze che seguivano una dieta ma non rispondevano a nessun criterio del DSM-IV per i DCA, e non le hanno neanche sottoposte a follow-up: questo secondo me è il grosso punto debole di questo studio (anche perché le persone indagate sono rimaste solo quelle che fin dall’inizio presentavano un comportamento borderline verso il DCA, il che ha probabilmente influenzato negativamente la significatività dei loro risultati).
Ad ogni modo, con le 81 interviste orali ottenute, i ricercatori hanno suddiviso le quindicenni in 4 gruppi mutualmente esclusivi (le cui descrizioni le traduco direttamente dallo studio in questione):
A dieta per vanità (in originale: “Vanity Dieters” – mi scuso per le pessime traduzioni di questi termini, ma non esiste un diretto equivalente in italiano) (28 ragazze). Le ragazze a dieta per vanità hanno iniziato la loro dieta per ottenere un corpo più snello, più sensuale e più appetibile, potremmo dire più in linea con gli standard della società odierna. Si mettono dunque a dieta con un obiettivo ben preciso, e generalmente la loro dieta prevede l’eliminazione di cibi ad alto contenuto calorico, dei dolci, associato ad un modesto incremento dell’attività fisica.
A dieta per sovrappeso (in originale: “Overweight Dieters”) (12 ragazze). Le ragazze a dieta per sovrappeso hanno iniziato la loro dieta per cercare di evitare la comparsa di quelle patologie che tipicamente si associano al sovrappeso e all’obesità (come per esempio il Diabete Mellito di tipo II, l’ipertensione arteriosa, la sindrome metabolica, etc…). La loro dieta è moderata, e anche l’esercizio fisico è contenuto e regolare. Questo gruppo include solo e soltanto ragazze che quando si sono messe a dieta erano oggettivamente sovrappeso (B.M.I.>25).
A dieta per sconquasso emotivo (in originale: “Depressed Dieters”) (33 ragazze). Le ragazze a dieta per sconquasso emotivo hanno iniziato la loro dieta in un momento particolarmente difficile della loro vita, che le aveva emotivamente molto scosse, con l’idea che le loro problematiche avrebbero potuto migliorare perdendo del peso. La tipologia di dieta è variabile tra queste ragazze, ma nella maggior parte dei casi è caratterizzata dal saltare pasti, abbuffarsi e poi vomitare, assumere lassativi, o fare tantissima attività fisica per regolare l’apporto energetico.
A dieta per bisogno di controllo (in originale: “Controllers Dieters”) (8 ragazze). Le ragazze a dieta per bisogno di controllo forniscono proprio questa spiegazione quando vengono chieste le motivazioni per cui la dieta è stata intrapresa: perché avevano bisogno di controllare tutto, anche l’alimentazione. Nella stragrande maggioranza dei casi sono ragazze originariamente normopeso o addirittura sottopeso. La loro dieta consiste nel ridurre progressivamente quantità e variabilità degli alimenti ingeriti.
[La descrizione dell’ultima categoria mi colpisce molto perchè personalmente me la ritrovo in pieno, dal momento che la mia restrizione alimentare è stata sempre strettamente legata alla mia necessità di sentire che tenevo tutto sotto controllo, alimentazione compresa.]
Fatta questa prima suddivisione in 4 gruppi, i ricercatori hanno considerato i primi 2 separatamente dagli altri 2: ai primi 2 gruppi è stato ascritto un basso rischio di sviluppare un DCA, viceversa gli ultimi 2 gruppi sono stati definiti come ad alto rischio di DCA.
Questa suddivisione è stata confermata ad un follow-up eseguito dopo 3 anni, ad Agosto 2013. Nelle persone appartenenti ai primi 2 gruppi, quelli considerato cioè a basso rischio, solo 3 persone avevano sviluppato un DCA subclinico, e nessuna un DCA conclamato. Viceversa, negli altri 2 gruppi, ovvero quelli considerati ad alto rischio, ben 10 avevano sviluppato un DCA subclinico, e addirittura 19 avevano sviluppato un DCA conclamato. Le differenze sono evidentemente statisticamente significative: le ragazze dei 2 gruppi ad alto rischio avevano una probabilità circa 15 volte maggiore di sviluppare un DCA rispetto alle altre. Notevole, come risultato.
Gli autori dello studio concludono:
“Quel che abbiamo scoperto ha palesi implicazioni cliniche: anche il solo chiedere da parte di genitori, insegnanti, allenatori, chiunque stia quotidianamente vicino alle adolescenti, il perché si sono messe a dieta, può dare un’idea della probabilità che quella ragazza possa sviluppare un DCA. Le ragazze che si mettono a dieta perché hanno delle difficoltà nella loro vita quotidiana o delle difficoltà emotive, o che sembrano eccessivamente attratte da un bisogno di controllo, devono essere strettamente monitorate. Lo studio suggerisce inoltre che le diete seguite dalle adolescenti sono sostanzialmente innocue, se non motivate dalle caratteristiche presenti negli ultimi 2 sottogruppi.”
(mia traduzione)
Anche se personalmente non penso che le ragazze originariamente effettivamente sovrappeso che si mettono a dieta debbano essere automaticamente considerate come soggetti a basso rischio di sviluppo di un DCA (poiché io credo che se la persona ha dei vissuti emotivi pesanti o delle manie di controllo, è comunque ad alto rischio, quale che sia il suo peso di partenza), penso che comunque i risultati di questo studio siano importanti ed interessanti, perché mostrano che, appunto, l’anoressia non è la mera conseguenza di una dieta finita male, ma è piuttosto successiva a problematiche psicologiche d’altro tipo. Inoltre questo studio permette, sebbene ovviamente in maniera approssimativa, di valutare sulla base delle motivazioni alla dieta, se la ragazza è effettivamente a rischio di sviluppare un DCA, o se la sua dieta è sostanzialmente innocua.
Etichette:
alimentazione,
anoressia,
binge,
BMI,
bulimia,
dca,
dieta,
Isomaa,
no pro ana,
peso,
ricerca,
ricovero,
studio scientifico
venerdì 3 maggio 2013
Focalizzare il denominatore
Recentemente ho scoperto una pubblicazione on-line inerente i disturbi alimentari che trovo davvero interessante. Mi riferisco all’ “International Journal of Eating Disorders”. Così, anche ieri mi sono messa a spulciare le novità pubblicate sull’ultima edizione.
Quello che mi ha colpito di più nell’edizione di questo mese è stato uno studio in particolare, non semplicemente per lo studio in sè, ma anche e soprattutto per i commenti che esso ha suscitato in chi lo ha letto, e che sono stati pubblicati dai rispettivi autori.
Cos’è venuto fuori da questo studio
I ricercatori (un gruppo di ricercatori degli U.S.A.) hanno valutato una serie di 942 adolescenti (età compresa tra i 14 e i 18 anni) che hanno afferito all’infermieria della scuola per varie ragioni (eh sì, non è solo una cosa dei telefilm, nelle scuole americane ci sono davvero delle infermierie!). A questi/e adolescenti è stato dato un questionario standardizzato, mirante a valutare (tra le altre cose) se questi/e ragazzi/e potessero avere o meno un qualsiasi disturbo alimentare. Il test cui mi riferisco è il questionario SCOFF, che vi riporto qua sotto. Rispondere “SI” a 2 o più domande è considerato diagnostico della presenza di un disturbo alimentare.
I ricercatori hanno anche valutato il BMI dei/delle ragazzi/e in questione, e se avessero problemi di alcool, droga, o se fossero fumatori. Interessante notare come il BMI fosse associato alla presenza di un qualche DCA, ma forse non nel modo che vi aspettereste: i/le ragazzi/e con BMI > 28 erano quelli/le che risultavano più frequentemente positivi/e al test – per la precisione, 3.2 volte più frequentemente associate alla presenza di comportamenti tipici da DCA rispetto agli adolescenti di cosiddetto “peso normale”.
Soprattutto, i ricercatori hanno osservato che ben il 16% delle persone mostrava segni della presenza di un DCA, e di questi circa il 30% erano maschi. Francamente, penso che questi numeri siano stati un po’ “pompati”, poiché a mio avviso il questionario SCOFF valuta più che altro le difficoltà che le persone possono avere nei confronti del proprio corpo e dell’alimentazione, non tanto la presenza di un DCA conclamato – ma questo esula da ciò che volevo dire in questo post.
Ma qual è il denominatore?
E questa domanda ci riporta ai commenti sottostanti l’articolo che ho letto. Uno in particolare mi ha colpito, ed è quello che dice:
“Trovo molto interessante questo studio relativo alla prevalenza dei DCA tra gli adolescenti di 14 – 18 anni che accedono all’infermieria scolastica. È per me sorprendente vedere che in uno screening di quasi 1000 persone, ben il 16% sono risultate positive per un DCA, perchè a quanto ne sapevo finora, avevo letto dappertutto che l’anoressia interessa circa l’1% della popolazione, la bulimia circa il 3%, e i DCAnas circa il 4%. Dunque, l’incidenza di queste malattie è marcatamente in aumento!!! Inoltre, è assolutamente inatteso per me il vedere che ben il 30% di queste persone sono ragazzi, quando il luogo comune è che i DCA interessino solo lo 0.1% della popolazione maschile. Grazie a questo articolo mi rendo invece conto che anche gli uomini hanno un elevato rischio di sviluppare un DCA.”
(mia traduzione)
Okay, qual è il punto. Il punto è che la popolazione sottoposta a screening non è, a mio avviso, sufficientemente eterogenea da rendere questo studio valido. Pensateci. Sono state screenate SOLO le persone che accedevano all’infermieria. Il che non significa che il 16% degli adolescenti abbia un DCA… significa soltanto che il 16% delle persone che sono finite in infermieria hanno risposto “SI” ad almeno 2 delle 5 domande del questionario SCOFF.
Ripeto: questo studio NON dimostra che il 16% degli adolescenti ha un DCA.
Anche se l’autore del commento che vi ho riportato non lo dice direttamente, in quello che scrive è implicito che crede che il 16% dei/delle ragazzi/e tra i 14 e i 18 anni abbia un DCA. Il fatto è che i ragazzi screenati erano solo quelli che accedevano all’infermieria… e in questa piccola popolazione selettiva e relativamente omogenea, pare abbastanza ovvio che chi va in infermieria possa avere un DCA, dati gli elevati livelli di co-morbidità che un disturbo alimentare comporta, sia da un punto di vista fisico che psichico. Oggettivamente, è molto più facile che finisca in infermieria una ragazza con un DCA piuttosto che una ragazza che si alimenta correttamente; il che rende ragione degli alti numeri riportati in questo studio.
Pertanto, secondo me non c’è alcuna dimostrazione che l’incidenza dei DCA sia vertiginosamente in aumento. Non credo che in precedenza siano mai stati fatti altri studi relativi alla percentuale di adolescenti con un effettivo DCA che si recavano nell’infermieria della scuola, quindi è impossibile dire se i numeri siano in aumento o in decremento rispetto al passato. Inoltre, il campione analizzato conta meno di 1000 persone, non è un lavoro fatto su grandi numeri, quindi mi chiedo come da un campione così numericamente limitato si possano estrapolare conclusioni di una qualche validità scientifica. Io immagino che ad oggi ci sia più informazione in merito ai DCA che non in passato, per cui le persone che ne sono affette sono più inclini a cercare aiuto (o vengono mandate dai genitori da qualche terapeuta, da qualsiasi parte si voglia vedere la cosa) ma, di nuovo, questo non significa che i DCA siano più frequenti che in passato.
Quando si legge un qualsiasi studio scientifico, credo sia sempre molto importante focalizzare qual è il denominatore dello stesso, ovvero la porzione, la “fetta” di popolazione che i ricercatori stanno effettivamente esaminando. Qui, la “popolazione” è quella degli adolescenti che si recano in infermieria. Se il questionario SCOFF fosse stato fatto compilare a pazienti ricoverate in un centro specializzato per il trattamento dei DCA, credo proprio che avremmo trovato il 100% di prevalenza all’interno di quella specifica popolazione... ma questo non significa che tutta la gente del mondo abbia un DCA. Perciò, qualora vi capitasse di leggere questo studio, niente allarmismi sul fatto che così tanti/e ragazzi/e abbiano un DCA, considerate le caratteristiche della popolazione che è stata sondata.
Questo studio lo reputo comunque importante perchè mostra che anche le infermierie scolastiche possono avere un ruolo importante nell’identificare una potenziale persona con DCA. Certo, probabilmente avranno millemila altre cose di cui occuparsi e preoccuparsi, ma è comunque utile saperlo, perché è possibile agire in questa direzione. Tra l’altro, a me non piace il questionario SCOFF (non mi piacciono i questionari in generale, perché penso siano riduttivi quantomeno in campo medico) ma ha per lo meno il pregio di essere rapido e diretto, quindi capisco perché possa essere stato deciso di utilizzarlo per uno studio del genere.
Quindi, penso che certamente questo studio abbia la sua utilità, ma stiamo sempre molto attente quando leggiamo gli studi relativi ai DCA, e siamo sempre molto caute nell’interpretarli, perché occorre prima valutare bene le circostanze che hanno portato a certi risultati.
Quello che mi ha colpito di più nell’edizione di questo mese è stato uno studio in particolare, non semplicemente per lo studio in sè, ma anche e soprattutto per i commenti che esso ha suscitato in chi lo ha letto, e che sono stati pubblicati dai rispettivi autori.
Cos’è venuto fuori da questo studio
I ricercatori (un gruppo di ricercatori degli U.S.A.) hanno valutato una serie di 942 adolescenti (età compresa tra i 14 e i 18 anni) che hanno afferito all’infermieria della scuola per varie ragioni (eh sì, non è solo una cosa dei telefilm, nelle scuole americane ci sono davvero delle infermierie!). A questi/e adolescenti è stato dato un questionario standardizzato, mirante a valutare (tra le altre cose) se questi/e ragazzi/e potessero avere o meno un qualsiasi disturbo alimentare. Il test cui mi riferisco è il questionario SCOFF, che vi riporto qua sotto. Rispondere “SI” a 2 o più domande è considerato diagnostico della presenza di un disturbo alimentare.
I ricercatori hanno anche valutato il BMI dei/delle ragazzi/e in questione, e se avessero problemi di alcool, droga, o se fossero fumatori. Interessante notare come il BMI fosse associato alla presenza di un qualche DCA, ma forse non nel modo che vi aspettereste: i/le ragazzi/e con BMI > 28 erano quelli/le che risultavano più frequentemente positivi/e al test – per la precisione, 3.2 volte più frequentemente associate alla presenza di comportamenti tipici da DCA rispetto agli adolescenti di cosiddetto “peso normale”.
Soprattutto, i ricercatori hanno osservato che ben il 16% delle persone mostrava segni della presenza di un DCA, e di questi circa il 30% erano maschi. Francamente, penso che questi numeri siano stati un po’ “pompati”, poiché a mio avviso il questionario SCOFF valuta più che altro le difficoltà che le persone possono avere nei confronti del proprio corpo e dell’alimentazione, non tanto la presenza di un DCA conclamato – ma questo esula da ciò che volevo dire in questo post.
Ma qual è il denominatore?
E questa domanda ci riporta ai commenti sottostanti l’articolo che ho letto. Uno in particolare mi ha colpito, ed è quello che dice:
“Trovo molto interessante questo studio relativo alla prevalenza dei DCA tra gli adolescenti di 14 – 18 anni che accedono all’infermieria scolastica. È per me sorprendente vedere che in uno screening di quasi 1000 persone, ben il 16% sono risultate positive per un DCA, perchè a quanto ne sapevo finora, avevo letto dappertutto che l’anoressia interessa circa l’1% della popolazione, la bulimia circa il 3%, e i DCAnas circa il 4%. Dunque, l’incidenza di queste malattie è marcatamente in aumento!!! Inoltre, è assolutamente inatteso per me il vedere che ben il 30% di queste persone sono ragazzi, quando il luogo comune è che i DCA interessino solo lo 0.1% della popolazione maschile. Grazie a questo articolo mi rendo invece conto che anche gli uomini hanno un elevato rischio di sviluppare un DCA.”
(mia traduzione)
Okay, qual è il punto. Il punto è che la popolazione sottoposta a screening non è, a mio avviso, sufficientemente eterogenea da rendere questo studio valido. Pensateci. Sono state screenate SOLO le persone che accedevano all’infermieria. Il che non significa che il 16% degli adolescenti abbia un DCA… significa soltanto che il 16% delle persone che sono finite in infermieria hanno risposto “SI” ad almeno 2 delle 5 domande del questionario SCOFF.
Ripeto: questo studio NON dimostra che il 16% degli adolescenti ha un DCA.
Anche se l’autore del commento che vi ho riportato non lo dice direttamente, in quello che scrive è implicito che crede che il 16% dei/delle ragazzi/e tra i 14 e i 18 anni abbia un DCA. Il fatto è che i ragazzi screenati erano solo quelli che accedevano all’infermieria… e in questa piccola popolazione selettiva e relativamente omogenea, pare abbastanza ovvio che chi va in infermieria possa avere un DCA, dati gli elevati livelli di co-morbidità che un disturbo alimentare comporta, sia da un punto di vista fisico che psichico. Oggettivamente, è molto più facile che finisca in infermieria una ragazza con un DCA piuttosto che una ragazza che si alimenta correttamente; il che rende ragione degli alti numeri riportati in questo studio.
Pertanto, secondo me non c’è alcuna dimostrazione che l’incidenza dei DCA sia vertiginosamente in aumento. Non credo che in precedenza siano mai stati fatti altri studi relativi alla percentuale di adolescenti con un effettivo DCA che si recavano nell’infermieria della scuola, quindi è impossibile dire se i numeri siano in aumento o in decremento rispetto al passato. Inoltre, il campione analizzato conta meno di 1000 persone, non è un lavoro fatto su grandi numeri, quindi mi chiedo come da un campione così numericamente limitato si possano estrapolare conclusioni di una qualche validità scientifica. Io immagino che ad oggi ci sia più informazione in merito ai DCA che non in passato, per cui le persone che ne sono affette sono più inclini a cercare aiuto (o vengono mandate dai genitori da qualche terapeuta, da qualsiasi parte si voglia vedere la cosa) ma, di nuovo, questo non significa che i DCA siano più frequenti che in passato.
Quando si legge un qualsiasi studio scientifico, credo sia sempre molto importante focalizzare qual è il denominatore dello stesso, ovvero la porzione, la “fetta” di popolazione che i ricercatori stanno effettivamente esaminando. Qui, la “popolazione” è quella degli adolescenti che si recano in infermieria. Se il questionario SCOFF fosse stato fatto compilare a pazienti ricoverate in un centro specializzato per il trattamento dei DCA, credo proprio che avremmo trovato il 100% di prevalenza all’interno di quella specifica popolazione... ma questo non significa che tutta la gente del mondo abbia un DCA. Perciò, qualora vi capitasse di leggere questo studio, niente allarmismi sul fatto che così tanti/e ragazzi/e abbiano un DCA, considerate le caratteristiche della popolazione che è stata sondata.
Questo studio lo reputo comunque importante perchè mostra che anche le infermierie scolastiche possono avere un ruolo importante nell’identificare una potenziale persona con DCA. Certo, probabilmente avranno millemila altre cose di cui occuparsi e preoccuparsi, ma è comunque utile saperlo, perché è possibile agire in questa direzione. Tra l’altro, a me non piace il questionario SCOFF (non mi piacciono i questionari in generale, perché penso siano riduttivi quantomeno in campo medico) ma ha per lo meno il pregio di essere rapido e diretto, quindi capisco perché possa essere stato deciso di utilizzarlo per uno studio del genere.
Quindi, penso che certamente questo studio abbia la sua utilità, ma stiamo sempre molto attente quando leggiamo gli studi relativi ai DCA, e siamo sempre molto caute nell’interpretarli, perché occorre prima valutare bene le circostanze che hanno portato a certi risultati.
Etichette:
anoressia,
binge,
bulimia,
DCAnas,
no pro ana,
prevalenza,
questionario SCOFF,
ricercatori,
ricovero,
statistica,
studio scientifico
Iscriviti a:
Post (Atom)